Perché l’oligopolio delle Big Tech è un problema per la collettività
Li chiamano già oligarchi, e la foto che li vede schierati in prima fila durante il giuramento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti è stata paragonata a quelle immagini in grado di immortalare un pezzo di storia e definire un nuovo potere. Stiamo parlando dei numeri uno delle Big Tech made in […]

Li chiamano già oligarchi, e la foto che li vede schierati in prima fila durante il giuramento di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti è stata paragonata a quelle immagini in grado di immortalare un pezzo di storia e definire un nuovo potere. Stiamo parlando dei numeri uno delle Big Tech made in Usa: il Ceo di Google Sunar Pichal, il fondatore di Meta Mark Zuckerberg, quello di Amazon Jeff Bezos, e accanto a loro la vera figura che fa da collante tra il mondo di questi colossi digitali, l’amministrazione Trump e una nuova destra in ascesa in diversi Paesi, ovvero Elon Musk.
Messi insieme, hanno il controllo di un vero e proprio impero che gestisce lo svolgimento di una notevole quantità di azioni che persone in tutto il mondo compiono nella vita di tutti i giorni.
Questa vicinanza tra il potere politico, raffigurato dal presidente Trump, e i colossi delle Big Tech, però, non si realizza solo in quella presenza simbolica in prima fila in un momento comunque molto importante come l’Inauguration Day. Dietro c’è molto di più. E il tema non riguarda solo Musk, il più coinvolto tra questi, al punto da aver ottenuto la guida di un dipartimento creato ad hoc per lui – il Department for Government Efficiency (Doge) – e da offrire supporto a partiti in tutto il mondo tramite la sua piattaforma X (fu Twitter), da cui è in grado di parlare a oltre 200 milioni di followers. Così come non riguarda solo le donazioni economiche fatte alla politica da queste aziende, contributi che rappresentano un fatto abbastanza comune negli Stati Uniti.
Prima del voto, abbiamo visto come Bezos, patron di Amazon ma anche editore del Washington Post, abbia rivendicato con un editoriale la decisione che il giornale non facesse alcun endorsement pubblico per le elezioni presidenziali: mossa interpretata come distensiva verso i repubblicani e verso Trump, che si apprestava a riconquistare la Casa Bianca.
E dopo il voto, abbiamo assistito a una retromarcia da parte di Zuckerberg su temi particolarmente osteggiati dalla destra trumpiana, come il fact-checking e i programmi di diversità, uguaglianza e inclusione nelle sue aziende. Questa scelta ha evidenziato il riallineamento di un’azienda, Meta, che solo quattro anni fa sospendeva dai suoi social l’account di Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill. E, più in generale, ha confermato un diverso atteggiamento da parte delle Big Tech rispetto a quell’approccio che viene spesso identificato come cultura (o talvolta ideologia) “woke” che proprio nelle piattaforme aveva trovato terreno fertile.
A briglie sciolte
Ma queste aziende, con un potere paragonabile a quella di vere e proprie superpotenze globali, cosa stanno ottenendo dalla loro vicinanza a Trump?
La seconda avventura del tycoon alla Casa Bianca è appena iniziata, ma ha già mostrato una stretta collaborazione con le Big Tech, con incontri mirati con i loro rappresentanti, e un’attenzione al settore che va ben oltre il sostegno, palesato anche in sede di giuramento, alle ambizioni spaziali di Musk.
Il presidente degli Stati Uniti, ad esempio, ha lanciato un ambiziosissimo piano per l’intelligenza artificiale, il più grande mai messo in campo, chiamato “Stargate Project”, che coinvolge aziende tech, banche e finanziatori vari e che punta a investire 500 miliardi di dollari per realizzare infrastrutture I.A. negli Usa entro il 2029.
Tuttavia, la misura che più di tutte rischia di favorire le Big Tech e rafforzare il loro oligopolio a livello non solo americano, ma anche globale, soprattutto nell’ottica trumpiana di uno scontro in materia tecnologica con la Cina, è la deregulation del settore.
Questa scelta politica, motivata con la volontà di poter innovare senza limiti, si è finora concretizzata nella decisione di rimuovere tutte le limitazioni sull’intelligenza artificiale imposte sotto la presidenza di Joe Biden e nella nomina dell’imprenditore tech David Sacks per redigere nuove linee guida in materie di I.A. e criptovalute.
Sacks, per la cronaca, fa parte di quel gruppo di imprenditori definiti come “PayPal Mafia”, di cui sono membri anche Musk e Peter Thiel, che hanno in comune l’aver lavorato insieme nella nota banca virtuale e aver poi lanciato imprese di successo. Secondo molti osservatori, la PayPal Mafia in questa fase si sta affiancando, se non in parte sostituendo, al deep state americano.
Una deregulation generalizzata, attraverso l’allentamento delle stringhe da parte delle autorità competenti, potrebbe innescare nuove acquisizioni e fusioni, che potrebbero a loro volta rendere le grandi aziende ancora più potenti. A partire dalle Big Tech, che vedrebbero così rafforzato il loro oligopolio.
Utenti sacrificati
Ma, al di là di questo aspetto, quali sono le conseguenze per il consumatore finale di una tecnologia sempre più in mano a poche aziende?
Partiamo da un presupposto. Le Big Tech, ovvero le cinque maggiori società americane del settore spesso elencate nell’acronimo “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), passando per quelle di Musk e tutte le altre, offrono servizi fondamentali per la nostra vita quotidiana. Tuttavia, proprio il fatto che tali servizi siano diventati asset così rilevanti, unito alla natura privata di tali aziende, conferisce loro un potere enorme, per cui un semplice malinteso può avere un duro contraccolpo sulla collettività senza che l’utente abbia un automatico diritto a far valere le proprie posizioni. Si tratta uno dei grandi temi di questo momento storico, un tema a cui l’Unione europea ha cercato di dare un ordine normativo, che però, di fronte al crescente potere di tali aziende, potrebbe non essere efficace.
C’è, poi, anche un discorso di qualità e di standardizzazione dei contenuti. Facciamo un passo indietro, e ripensiamo a cosa era Internet alla fine degli anni Novanta, quando iniziò ad avere una diffusione fattasi poi, via via, più capillare.
Il minor numero di utenti faceva di questa infrastruttura un luogo più elitario e meno partecipato. Ma, mettendo da parte ricordi romantici sul suono della connessione 56k, sui vecchi design dei siti e su come stessimo tutti scoprendo una sorta di mondo nuovo, possiamo anche osservare come allora la Rete fosse uno spazio più democratico rispetto a oggi.
A quel tempo, intanto, Internet passava molto di più attraverso i siti, dal momento che le piattaforme erano pressoché inesistenti. I motori di ricerca erano molteplici e Google era solo uno dei tanti, seppur decisamente diffuso, che andava ad affiancarsi in primis a un Yahoo ben più popolare di oggi e ad AltaVista, chiuso da ormai oltre dieci anni e finito nel cassetto dei ricordi. Così come era più frequente usare motori di ricerca italiani, che si chiamassero Libero o Arianna, Virgilio o SuperEva.
All’epoca, se un’attività commerciale voleva essere presente online o se si voleva lanciare un nuovo progetto, la prima cosa da fare era realizzare un sito web. Oggi, invece, si apre una pagina su una o più piattaforme social già esistenti. Più comodo e più adatto a questi tempi, senz’altro. Ma questo cambiamento – per quanto qualsiasi sito necessitasse anche prima di un server, offerto da un’azienda tecnologica – dà anche l’idea di quanto le Big Tech abbiano aumentato la propria influenza.
Se ciò ha portato magari a maggiori comodità, almeno per come siamo abituati a usare Internet oggi, d’altro canto pone molti quesiti sulla standardizzazione dei contenuti e sulla qualità dei servizi prestati.
Durante il periodo del Covid, abbiamo assistito a un aumento della popolarità delle piattaforme, in seguito al quale però molti social hanno dovuto rivedere il proprio modello, talvolta prendendo spunto dai servizi degli altri – con una conseguente standardizzazione del servizio offerto – e talvolta sacrificando la “user experience” in nome di contenuti sponsorizzati e a pagamento.
Risultati non sempre positivi per gli utenti, che hanno portato lo scrittore e giornalista canadese-britannico Cory Doctorow a coniare un termine che definisce il declino delle piattaforme: «enshittification», che in italiano potremmo tradurre con – si perdoni il termine – «merdificazione». Nello spiegare questo concetto, Doctorow ha delineato un ciclo di declino delle piattaforme: esse partono come molto positive per l’utente; poi, però, quest’ultimo viene sacrificato a beneficio dei clienti disposti ad investire per promuovere i loro business; successivamente, anche questi sono a loro volta sacrificati per ottenere maggiori profitti; alla fine, il rischio concreto è che la piattaforma muoia.
Molti utenti hanno trovato elementi compatibili con questa ricostruzione nella vita di diversi social, motori di ricerca, servizi di e-commerce e chi più ne ha più ne metta.
Effettivamente, un sito che ha spostato il suo pubblico su un social oggi ha molta difficoltà a raggiungere una parte consistente dei suoi followers senza pagare un’apposita campagna, così come i risultati delle ricerche su qualsiasi portale sono fortemente influenzate dai contenuti a pagamento.
Tutto ciò è regolato sulla base di un algoritmo deciso da un’azienda privata nella Silicon Valley e su cui raramente l’utenza ha gli strumenti per essere informata. Con il risultato che, spesso, per inseguire questo algoritmo i vari creatori finiscono per dar vita a contenuti sempre più simili tra loro, in un processo che favorisce una crescente standardizzazione.
Oligopolio, peraltro, non significa solo questo: una maggiore concorrenza può portare anche a maggiore autocontrollo.
Quando alla fine degli anni Duemila è arrivato nelle nostre vite Facebook, ad esempio, nemmeno avevamo un termine per definirlo. Di lì a breve abbiamo capito che i social network – quella era la parola che cercavamo – avrebbero stravolto totalmente la nostra vita. E, sia chiaro, rappresentano una grande innovazione e un ottimo servizio, ma il loro impatto ci ha decisamente presi alla sprovvista sotto molti punti di vista. Un domani, qualcosa del genere potrebbe accadere con ulteriori innovazioni, si chiamino esse intelligenza artificiale o realtà aumentata: chi dovrà fare in modo che gli esseri umani non rimangano presi in contropiede?
Nel dibattito in corso non c’è una risposta univoca, ma è verosimile che una situazione di oligopolio può rappresentare un problema a riguardo.
E l’Europa che fa?
Mentre gli Stati Uniti forniscono sempre più strumenti di crescita alle loro Big Tech nell’ottica di una lotta sul terreno dell’innovazione digitale con la Cina, cosa fa l’Europa?
Oltreoceano circola il detto «America innovates, China replicates, Europe regulates» che dà l’idea di come l’avversario in materia per la Silicon Valley sia Pechino e di come l’Europa si sia ritagliata un mero ruolo di regolatore in questa contesa.
Tuttavia, se queste aziende tecnologiche sono diventate ormai delle superpotenze più influenti dei governi di molti Paesi, anche l’attività regolatoria da parte dell’Ue rischia di essere molto difficile da esercitare. Bruxelles, infatti, potrebbe non avere più sufficiente potere negoziale per mettere ordine in un settore che rischia di crescere in maniera incontrollata e prendere il nostro continente alla sprovvista.
L’unica via che consentirebbe all’Europa di giocare un ruolo da protagonista sarebbe dotarsi di asset propri in materia tecnologica: è vero, sono investimenti molto elevati, ma sono anche fondamentali. L’America è senza dubbio un partner privilegiato e un amico naturale dell’Ue: non va vista come un concorrente, ma come un alleato insieme a cui crescere con uno scambio in cui ognuno possa prendere il meglio dall’altro. Ma senza un investimento in questi asset ciò non è possibile. Si rischierebbe di soccombere e lasciare il nostro continente in balia di una totale irrilevanza in un settore fondamentale.



































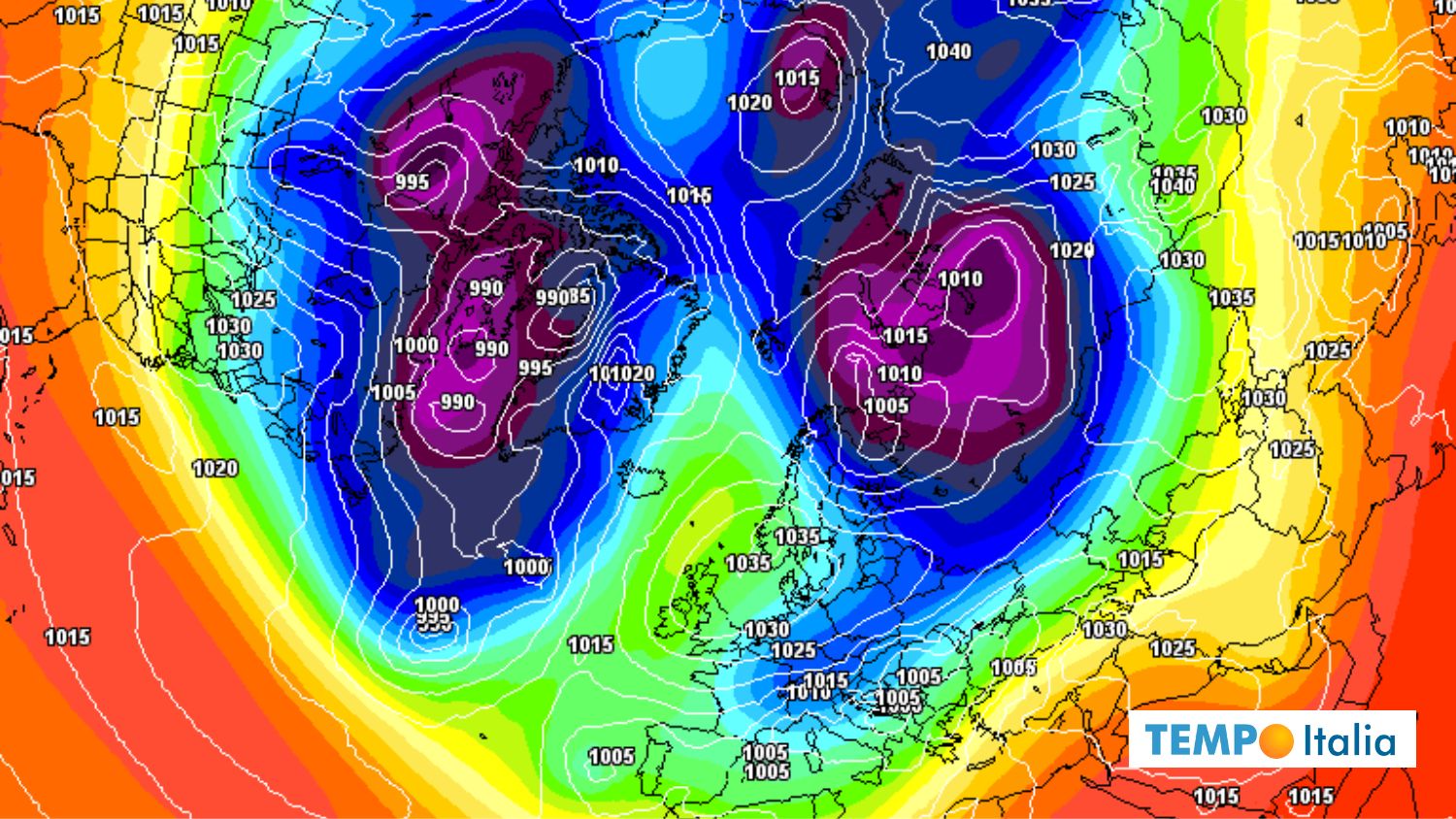









/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095135-83040364-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095159-83040844-310-310.png)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095172-83041104-310-310.jpg)





