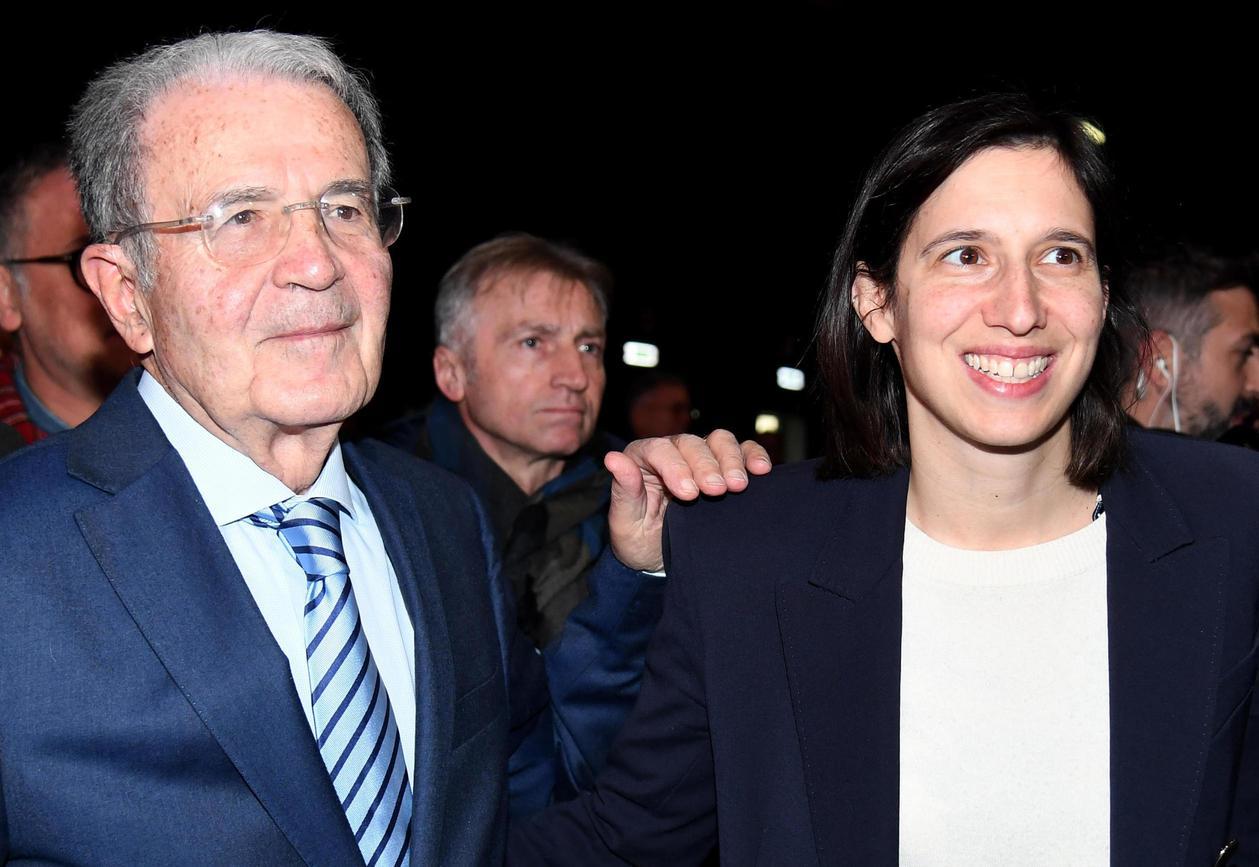Viaggio a Kobane: nel cuore della rivoluzione confederalista del Kurdistan
Al confine tra Iraq, Siria e Turchia c’è un ponte galleggiante che attraversail fiume Tigri. Siamo nel cuore del Kurdistan, il Paese che, per volere delle potenze europee e degli imperi ottomano e persiano, non è mai esistito, e che oggi è diviso tra Turchia, Iran, Siria e Iraq. Da 13 anni, l’unico modo ufficiale […] The post Viaggio a Kobane: nel cuore della rivoluzione confederalista del Kurdistan appeared first on L'INDIPENDENTE.

Al confine tra Iraq, Siria e Turchia c’è un ponte galleggiante che attraversail fiume Tigri. Siamo nel cuore del Kurdistan, il Paese che, per volere delle potenze europee e degli imperi ottomano e persiano, non è mai esistito, e che oggi è diviso tra Turchia, Iran, Siria e Iraq. Da 13 anni, l’unico modo ufficiale per entrare in Rojava, regione siriana del Kurdistan, è necessario affrontare lunghi controlli di frontiera alla dogana irachena, attraversando gli uffici decorati dalle immagini del leader curdo Masoud Bazoum. Una volta attraversato il ponte ed entrati in Sira, tuttavia, è il ritratto di Abdullah Öcalan a tappezzare gli edifici. Leader e fondatore del PKK (Partito dei Lavoratori Curdi), Öcalan si trova in isolamento nelle prigioni turche da quasi 26 anni. A lui si attribuisce l’ideazione del confederalismo democratico come alternativa di governo decentralizzato per il Kurdistan e per tutto il Medio Oriente. Un’idea di democrazia diretta che vuole andare oltre lo stato nazione, che favorisce l’autogoverno dei popoli e mira a dare uguale rappresentanza a tutte le minoranze e alle donne. E la città di Kobanê è uno dei simboli di questa rivoluzione.
Il Rojava è una lingua di terra che si estende da Kobanê fino al confine con l’Iraq, e si trova proprio tra i fiumi Tigri ed Eufrate. Da qui è partita la rivoluzione confederalista, che attraverso un sistema organizzativo su base comunalista, dalla dimensione del quartiere fino a quella della provincia, ha delineato una forma istituzionale dove il potere politico, economico e giudiziario sono decentralizzati e dove ogni carica istituzionale è presieduta sia da un uomo che da una donna. Si tratta tutt’oggi di un esperimento, che ogni giorno cambia e va migliorando grazie alla costituzione della DAANES (Amministrazione Autonoma della Siria del nord-est), che oggi amministra più di un terzo della Siria, superando i confini della regione curda. Nonostante il progetto rivoluzionario sia stato avviato e rimanga condotto dai curdi, perseguitati dal regime Baathista per oltre cinquant’anni, sotto l’ombrello della DAANES vivono per la maggior parte arabi, ma anche turkmeni, ceceni, assiri, siriaci, yazidi, armeni. Man mano che il progetto confederalista cresceva, sempre più comunità prendevano parte alle istituzioni di autogoverno, portando i loro interessi e i loro diritti all’interno dell’unico progetto rivoluzionario del secolo corrente. Si espandeva il confederalismo e insieme a esso veniva sconfitto Daesh, villaggio per villaggio, dalle Forze Democratiche Siriane (SDF), coalizione delle forze militari democratiche della regione a trazione YPG-YPJ (le unità di difesa popolare curde miste e delle donne).

La liberazione di Kobanê, dieci anni dopo
Nei giorni scorsi in Rojava si è festeggiato il decennale della liberazione di Kobanê da Daesh. La città è uno dei simboli della rivoluzione confederalista: da qui inizia la controffensiva a danno dello Stato Islamico. La liberazione di Kobanê è il momento in cui il confederalismo democratico sembra davvero un’alternativa di governo nella regione. A dieci anni da questi eventi in Siria è l’alba di una nuova era. Per la DAANES è un momento cruciale: il progetto confederalista ha la possibilità di giocare un ruolo importante per il futuro della Siria unita. Dopo tanti anni potrebbe essere il momento di deporre le armi, ma dall’altro lato del tavolo negoziale le fazioni comandate da Al-Jolani, molto vicine alla Turchia di Erdogan, non hanno ancora dimostrato concretamente di essere intenzionati a includere tutti, in particolare i curdi, nella costruzione di una Conferenza Nazionale per disegnare la Siria di domani. «Nelle zone in cui ha preso il potere HTS stiamo già vedendo persone minacciate e perseguitate per la loro etnia o religione. Cristiani, yazidi, alawiti… Abbiamo certamente bisogno di un conferenza nazionale, ma questa deve essere sotto l’ombrello delle Nazioni Unite, affinché sia concesso a tutte le parti della società di parteciparvi ed essere rappresentate» mi dice Gharib Hassou, il neo eletto co-segretario del PYD, primo partito nel Kurdistan Siriano. «A Damasco vediamo Al Jolani insieme agli emiri dell’Isis, di Al Nusra e di tante altre fazioni islamiche fondamentaliste», aggiunge. «Abbiamo combattuto 13 anni e siamo stanche. Se ci garantiranno i nostri diritti in quanto donne e in quanto curde, lasciandoci la facoltà di proteggere ciò ci siamo guadagnate in questi anni, allora deporremo le armi», mi confida Emine Ose, tra le donne del Kongra Star che ho incontrato nella città di Quamishli, roccaforte della DAANES. Il suo messaggio è chiaro: «se ci sarà dialogo non ci sarà bisogno di armi. Se invece ci offriranno oppressione, non abbasseremo la testa».
La lotta per la diga
I combattenti e le combattenti delle SDF, YPG e YPJ non hanno ancora deposto le armi. A pochi chilometri da Kobanê devono difendere la diga di Tishreen, dove ogni giorno centinaia di civili si recano per protestare pacificamente e difendere una delle infrastrutture più importanti della regione per le risorse idrighe ed elettriche. Ogni giorno in centinaia vengono feriti. Molti vengono uccisi dai droni turchi. A poche decine di chilometri più a ovest il fronte contro la SNA (l’Esercito Nazionale Siriano), milizie mercenarie a prevalenza Turkmena che portano avanti l’agenda Turca nel Nord della Siria. «Due mesi fa è caduto il regime di Assad, e quasi un mese fa sono iniziati gli scontri alla diga dopo che abbiamo perso Manbij. Il nuovo governo deve decidere se vuole difendere il loro paese dalle violenze dei nostri vicini», afferma Rohilat Afrin, la comandante in capo alle Ypj, mentre accoglie una delegazione internazionale di solidali nel quartier generale vicino ad Hasake. E manda un messaggio chiaro al nuovo presidente della Siria: andare a braccetto con Erdogan significa scegliere di non difendere il proprio paese dalle ingerenze esterne.

La Turchia vuole impossessarsi della diga di Tishreen, sul fiume Eufrate, per tagliare i rifornimenti di acqua e di energia elettrica della città. Kobanê è chiusa a nord dal confine e a ovest dalle terre occupate nel 2018 a seguito dell’operazione Ramoscello d’ulivo, durante la quale la Turchia ha occupato diverse città importanti tra cui Afrin, obbligando più di 400.000 persone a lasciare la propria casa. Quegli stessi sfollati ora scappano dalle zone limitrofe a Manbij, presa dalle SNA dopo la caduta del regime. «La Turchia colpisce intenzionalmente i civili. Mira bambini, donne e anziani. Mio padre è appena stato ferito alla diga» mi dice Zehra, dottoressa di Kobanê, nella piazza dei Martiri dove si stanno volgendo le celebrazioni della liberazione. Abdul, professore universitario sui 50, si avvicina deciso per farmi capire chiaramente di cosa stiamo parlando. «Siamo tutti un bersaglio per la Turchia, e infatti resistiamo tutti, anziani e bambini. I nostri figli sono al fronte, quindi noi continueremo. Non abbiamo paura». In tutto il territorio amministrato dalla DAANES sono tantissimi i civili che raccontano la loro esperienza alla diga. Con molti è difficile fissare un appuntamento «domani devo andare a Tishreen». Con i loro corpi si interpongono tra il diritto ad una vita dignitosa e ai crimini di guerra di un paese NATO.
Oltre ai loro diritti difendono la rivoluzione, per la quale Kobanê è un simbolo importantissimo. «Qui abbiamo sconfitto l’Isis. E abbiamo pagato con la vita di migliaia di giovani martiri». E sono in migliaia, nonostante la guerra a pochi chilometri, le persone che lo scorso 26 gennaio hanno preso parte alle celebrazioni per il decennale dalla liberazione. A Kobanê sono sicuri che da questa resistenza ne usciranno vittoriosi. «Vinceremo e continueremo a resistere. Dieci anni fa eravamo bambini, ora combattiamo noi al fronte per difendere la rivoluzione», mi dice Kawa, 22 anni. Jassur, Omar e Wael corrispondono all’identikit del compagno. Hanno rispettivamente 20, 22 e 20 anni. Sono combattenti dell’esercito a difesa della città. «Mio fratello e i miei vicini di casa sono al fronte. Pochi giorni fa siamo andati anche noi alla diga e insieme a noi sono morti una coppia, marito e moglie. Loro figlio ha 2 anni e ora è orfano», dice Jassur. Oltre alla piazza anche il cimitero dei martiri di Kobanê è teatro di numerose celebrazioni, oltre che di frequenti riti funebri, dato che ogni giorno qualche giovane combattente perde la vita. Mi avvicino a una signora che con la famiglia piange sulla tomba del marito, morto nel 2018 sempre durante la guerra con i turchi. «Adesso anche mio figlio è diventato un martire alla diga, pochi giorni fa». Dice dirigendosi verso la sezione del cimitero dove i corpi sono ancora seppelliti a terra perché deceduti da poco.
«Nello stesso giorno abbiamo liberato questa città e abbiamo protetto tutto il mondo. Allo stesso modo proteggeremo la diga per tutelare tutta la Siria. Da Kobanê a Damasco». Le parole di Asisa, anche lei presente in piazza, dicono molto del momento che potrebbe vivere il popolo siriano tutto in questo momento. Dopo 13 anni in cui il Paese ha fatto da scacchiera per le grandi potenze esterne, oggi i siriani possono autodeterminarsi se veramente costruiscono una prospettiva di unità. Sta ai diversi attori che hanno composto la rivoluzioni siriane: sia quelle democratiche che quelle islamiste. È un momento cruciale e di cambiamento anche per tutto il popolo curdo. Da un lato l’incontro ufficiale di poche settimane fa tra Masoud Barzani e il generale Mazlum Abdi – comandante generale delle SDF – ne è la dimostrazione. Fino a poco tempo fa i rapporti dell’amministrazione autonoma con i curdi “barzaniani” non erano così distesi, per via principalmente del loro legame con Erdogan. Dall’altro è significativo il fatto che dopo molto tempo si stiano iniziando a smuovere le acque sulla liberazione di Abdullah Ocalan. «Se ci saranno veramente progressi sulla liberazione di Ocalan, allora prenderemo seriamente quelle che per adesso sono ancora parole. Se Ocalan davvero prenderà parola, questo potrebbe avere implicazioni decisive per la pace in Kurdistan. Erdogan però sta intensificando il conflitto», mi dice sempre Gharib Hassou. «Come curdi in Siria», riprende, «siamo stati perseguitati per cento anni. Da un lato dobbiamo risolvere la questione curda e dall’altro dobbiamo fare in modo che cessino gli attacchi turchi. Stiamo organizzando una Conferenza Nazionale Curda proprio per capire come procedere su questi due fronti».
Il tradimento occidentale
Molte potenze giocano tuttavia ancora un ruolo fondamentale nell’area. Primi tra tutti gli americani, a capo della coalizione internazionale che ha supportato le SDF nella sconfitta di Daesh sul campo. «Non ci hanno aiutato a sconfiggere l’Isis. Hanno aiutato loro stessi», mi dice Arad, ex combattente curdo. «Non mi piace che siano qui, ma al tempo stesso questo ci tutela dalla minaccia di un’invasione turca». Fa riferimento ai quasi 2000 soldati presenti nelle due basi militari ad Hasake. Pochi giorni fa proprio qui la popolazione locale protestava per l’ipocrisia americana, sostenendo che gli Stati Uniti occupano il territorio curdo solo per i propri interessi. I rapporti istituzionali però, per forza di cose data la situazione, sono positivi. Sia Mazlum Abdi che Elhan Ahmad, tra le figure più importanti della DAANES a livello politico, sono stati invitati all’insediamento di Trump alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio. La recente decisione di Trump di sospendere per tre mesi gli aiuti umanitari americani non va tuttavia esattamente nella direzione di una partnership solida per sconfiggere definitivamente Daesh. Sebbene questa sia la ragione ufficiale della presenza militare degli Stati Uniti in Rojava, l’immediata sospensione degli aiuti umanitari ha causato il licenziamento di quasi mille operatori umanitari soltanto nei campi di Al Hol e Roj, dove sono detenute le famiglie dei combattenti dell’Isis, provenienti da tutto il mondo. Specialmente negli ultimi mesi, da quando la Turchia ha ricominciato gli attacchi a danno della DAANES, la gestione del campo è sempre più complessa. «Fermare improvvisamente i progetti umanitari aumenterà le condizioni di disagio e di povertà nei campi e nelle zone che più sono state colpite da Daesh. Alcuni progetti erano pensati proprio per allontanare i giovani dal terrorismo nero. Ora avranno una strada spianata per reclutare giovani disperati che non hanno alternative. Magari offrendo soldi alle famiglie per farsi esplodere in un centro abitato», mi spiega M., una fonte che ha lavorato come coordinatore di progetti del US Aid, che preferisce rimanere anonimo.

Da quando HTS ha preso Damasco i campi erano già in subbuglio. I detenuti pensano che Al-Jolani li libererà, e non si tratta per forza di speculazioni dopo che sono di recente apparsi al suo fianco alcuni tra i più importanti esponenti di Daesh. Anche per questo, oltre al suo passato di affiliazione con Al Qaeda, la maggior parte delle persone in Rojava non si fidano di lui. In particolare le donne: «dentro la DAANES i nostri diritti sono garantiti, ma nelle zone governate da HTS abbiamo paura che non sarà lo stesso», mi dice Asisa, responsabile del centro per i disabili di Kobanê. «Da Al Jolani non vogliamo dichiarazioni ma fatti. Ci saranno discussioni democratiche a cui potremo partecipare o no? Le YPJ vogliono rimanere parte dell’esercito mantenendo la nostra autonomia», di nuovo la comandante in capo delle YPJ Rohilat Afrin. E ancora la rappresentante dell’assemblea delle donne Kongra Star: «nel governo temporaneo non c’è nemmeno una donna. Senza donne non c’è futuro democratico».
Era il 5 ottobre del 2014, e proprio una donna, Arin MIxran, combattente delle YPJ ha dato il via alla liberazione di Kobanê facendosi esplodere tra i miliziani di Daesh disarmandoli dell’artiglieria più pesante e della postazione più strategica per l’assedio, la collina di Mishtenur. Grazie al suo sacrificio e a quello di altre figure leggendarie della siria rivoluzionaria come Faysal Abu Leyla, combattente mezzo arabo e mezzo curdo del battaglione del Sole del Nord, Kobanê è stata liberata e la prima rivoluzione del nostro secolo ha preso forma in una delle regioni più conservatrici del pianeta. Se oggi Kobanê cade non si abbandonano soltanto le persone che hanno sacrificato tutto per sconfiggere un cancro globale. Far cadere Kobanê significa lasciar morire un’esperienza che per tutti noi lotta contro i numerosi cancri che attanagliano le nostre società: il patriarcato, il razzismo e le disuguaglianze dell’iper capitalismo.
[di Mosè Vernetti]
The post Viaggio a Kobane: nel cuore della rivoluzione confederalista del Kurdistan appeared first on L'INDIPENDENTE.









































/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095091-83039484-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095167-83041004-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095133-83040324-310-310.jpg)
/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095244-83042544-310-310.png)