Agrivoltaico, quali contratti con i partner agricoli?
I rapporti tra chi coltiva e chi produce energia sono fondamentali per lo sviluppo dell’agrivoltaico. Per questo motivo abbiamo chiesto questo contributo a Green Horse Legal Advisory. Una delle autrici dell’articol, Celeste Mellone, approfondirà l’argomento anche nel corso del convegno “Agrivoltaico oltre il Pnrr: innovazione e sostenibilità per le aziende agricole italiane”, che QualEnergia.it ha […] The post Agrivoltaico, quali contratti con i partner agricoli? first appeared on QualEnergia.it.

I rapporti tra chi coltiva e chi produce energia sono fondamentali per lo sviluppo dell’agrivoltaico. Per questo motivo abbiamo chiesto questo contributo a Green Horse Legal Advisory.
Una delle autrici dell’articol, Celeste Mellone, approfondirà l’argomento anche nel corso del convegno “Agrivoltaico oltre il Pnrr: innovazione e sostenibilità per le aziende agricole italiane”, che QualEnergia.it ha organizzato per la mattina di mercoledì prossimo, 29 gennaio, a Verona, nell’ambito di Fieragricola Tech.
Il giorno successivo, giovedì 30, sempre nell’ambito della manifestazione alla fiera di Verona, parleremo ancora di agrivoltaico con un secondo convegno:“L’agrivoltaico verticale e bifacciale in Italia”.
La disciplina integrata introdotta inizialmente dalle linee guida in materia di impianti agrivoltaici, e successivamente, dal cosiddetto Dm Agrivoltaico, unitamente alle regole operative e alle linee guida per il monitoraggio della continuità dell’attività agricola emanate dal Crea e dal Gse, ha evidenziato l’urgente necessità di perfezionare la contrattualistica necessaria per le fasi di sviluppo e di esercizio degli impianti agrivoltaici.
Il funzionamento della partnership tra agricoltori e produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili è, dunque, oggetto di una prima, cruciale verifica sul campo. La sinergia richiesta tra attività agricole (attività di coltivazione o zootecnia) e attività di produzione di energia da fonte rinnovabile necessaria affinché un impianto possa qualificarsi come agrivoltaico (oltre al possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di settore) comporta una doppia analisi: da un lato, la qualifica soggettiva del proponente, che deve includere l’effettivo esercizio dell’attività agricola e, dall’altro, la disponibilità dei terreni.
L’approfondimento di entrambi i profili richiede un approccio multidisciplinare e trasversale al problema, venendo in rilievo, da una parte, l’aspetto tecnico delle modalità di svolgimento dell’attività agricola nonché dei profili di responsabilità in capo a entrambi gli operatori (specialmente in materia previdenziale e assistenziale) e, dall’altra, l’adattamento di format contrattuali per la disponibilità dei terreni che, per la prima volta, incontrano interlocutori di settori diversi.
Inutile dire – senza il rischio di risultare iperbolici – che dopo la nefasta esperienza delle serre, questo è il primo reale tentativo di suggellare la sinergia tra le due attività in modelli contrattuali, idonei a superare la prova della bancabilità.
Requisiti soggettivi
Per accedere ai bandi del Dm Agrivoltaico, è indispensabile che il soggetto responsabile dello sviluppo e della gestione dell’impianto sia qualificato come:
- Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., in forma individuale o societaria; oppure
- ATI (Associazione Temporanea di Imprese), che includa almeno un operatore agricolo. In quest’ultimo caso, la partnership agricola è regolata nell’ambito dell’ATI, fermo restando che l’operatore agricolo deve garantire la disponibilità dei terreni conformemente ai requisiti AGEA per la tenuta del fascicolo aziendale.
Nessun requisito soggettivo è, invece, previsto in generale per lo sviluppo e realizzazione di impianti agrivoltaici che non accedano agli incentivi e ai contributi in conto capitale ai sensi del Dm Agrivoltaico, eccezion fatta per talune disposizioni regionali (quali quelle lombarde di cui alla d.G.R. n. XII/2783) che hanno, in maniera del tutto contestabile, previsto stringenti requisiti soggettivi in capo ai proponenti di impianti agrivoltaici.
Non stupisce che tale deliberazione sia stata impugnata, nelle more dell’implementazione da parte delle Regioni della disciplina sulle aree idonee, in conformità al cd. Dm Aree Idonee.
La disponibilità dei terreni
La disponibilità dei terreni, e il conseguente rapporto contrattuale con il partner agricolo, è il fulcro dello sviluppo degli impianti agrivoltaici. L’interazione tra normativa agricola e contrattualistica genera complessità, incluse implicazioni catastali e notarili.
Tralasciando l’ipotesi della proprietà dei terreni in capo al titolare dell’autorizzazione, che può quindi disporne pienamente, in caso di costituzione del diritto di superficie sui terreni, è necessario chiarire se tale diritto consenta anche l’uso agricolo. Per evitare ambiguità, è prassi specificare nei contratti la facoltà di utilizzo del suolo e del sottosuolo per attività agricole, mediante:
- una clausola specifica nell’atto di costituzione del diritto di superficie, che chiarisca la portata dei diritti in capo al concessionario; oppure
- la costituzione di un diritto di usufrutto, che offre maggiore certezza giuridica perché suscettibile di autonoma trascrizione nei registri immobiliari.
Tipologie contrattuali
La scelta del modello contrattuale per affidare l’attività agricola è determinata dalla natura del titolo giuridico sui terreni. Le opzioni principali includono:
(i) contratto di affitto di fondo rustico: tipico ma formalmente rigido. Più in particolare, questa tipologia di contratto ha il pregio della tipicità del contratto agrario ma risulta particolarmente “ingessato” nei formalismi richiesti per l’adozione delle disposizioni in deroga alla L. n. 203/1982 – questi contratti sono tipizzati nei contenuti ex lege, ad esempio la durata è quindicennale. Le parti possono inserire disposizioni contrattuali in deroga ma ciò è possibile soltanto attraverso la partecipazione all’atto dell’associazione di categoria. Tale partecipazione potrebbe risultare “d’intralcio” per soddisfare le esigenze del titolare dell’autorizzazione – e alla competenza della sezione agraria in caso di controversie, con un tendenziale favor nei confronti dell’agricoltore;
(ii) contratto di comodato: con una struttura flessibile ma con il rischio di riqualificazione come contratto agrario e, quindi, assoggettabile alla competenza della sezione agraria. Per il motivo di cui sopra – tendenziale favor – e della negoziazione di pattuizioni in deroga alla disciplina del codice civile, per quanto riguarda – ad esempio – la possibilità di recesso, prevista sempre ex lege nei confronti dell’agricoltore;
(iii) contratto di servizi agricoli: più garantista per il titolare dell’autorizzazione in termini di scioglimento del rapporto contrattuale ma, indubbiamente, problematico in termini di responsabilità solidale per lo svolgimento dell’attività agricola, con tanto di risvolti giuslavoristici e previdenziali.
Dirimente nella scelta dei modelli contrattuali indicati è il titolo in forza del quale il titolare dell’autorizzazione dispone dei terreni e l’allocazione della responsabilità per lo svolgimento dell’attività agricola.
Nondimeno, bisogna tenere a mente che di per sé il contratto di servizi agricoli, poiché si limita a instaurare un rapporto a livello meramente contrattuale con l’agricoltore, di gestione e coordinamento dell’attività agricola, senza conferire alcun titolo autonomo per la disponibilità dei terreni non è idoneo alla tenuta del fascicolo aziendale.
A questo scopo, è necessario quindi che il titolare dell’autorizzazione conceda al soggetto agricolo i terreni, in forza di uno dei titoli ammessi da Agea (comodato, affitto, usufrutto, uso, ecc).
Conclusioni
La poca familiarità che gli operatori del mercato dell’energia hanno con questi rigidi schemi contrattuali che connotano la gestione dell’attività agricola e l’inaspettata esigenza di coinvolgere attivamente i partner agricoli per finalizzare i loro investimenti, ha palesato l’inadeguatezza degli strumenti che attualmente gli operatori agricoli hanno per fronteggiare e gestire al meglio la combinazione dello svolgimento delle due attività.
Per ovviare ai rischi della novità della materia e della sinergia tra due mondi, sorti originariamente come l’uno escludente l’altro (quantomeno fino all’avvento dell’agrivoltaico), l’approccio trasversale alle criticità e alle peculiarità della materia non può che essere quello vincente.
La valutazione dei progetti caso per caso consente di comprendere meglio e incontrare le aspettative degli attori coinvolti, garantendo, da una parte, il mantenimento dell’efficacia del titolo autorizzativo grazie al monitoraggio e, dall’altra, un corretto svolgimento dell’attività agricola, che sia esente da qualsivoglia contestazione e sanzione, emessa dalle autorità di settore preposte ai controlli.The post Agrivoltaico, quali contratti con i partner agricoli? first appeared on QualEnergia.it.













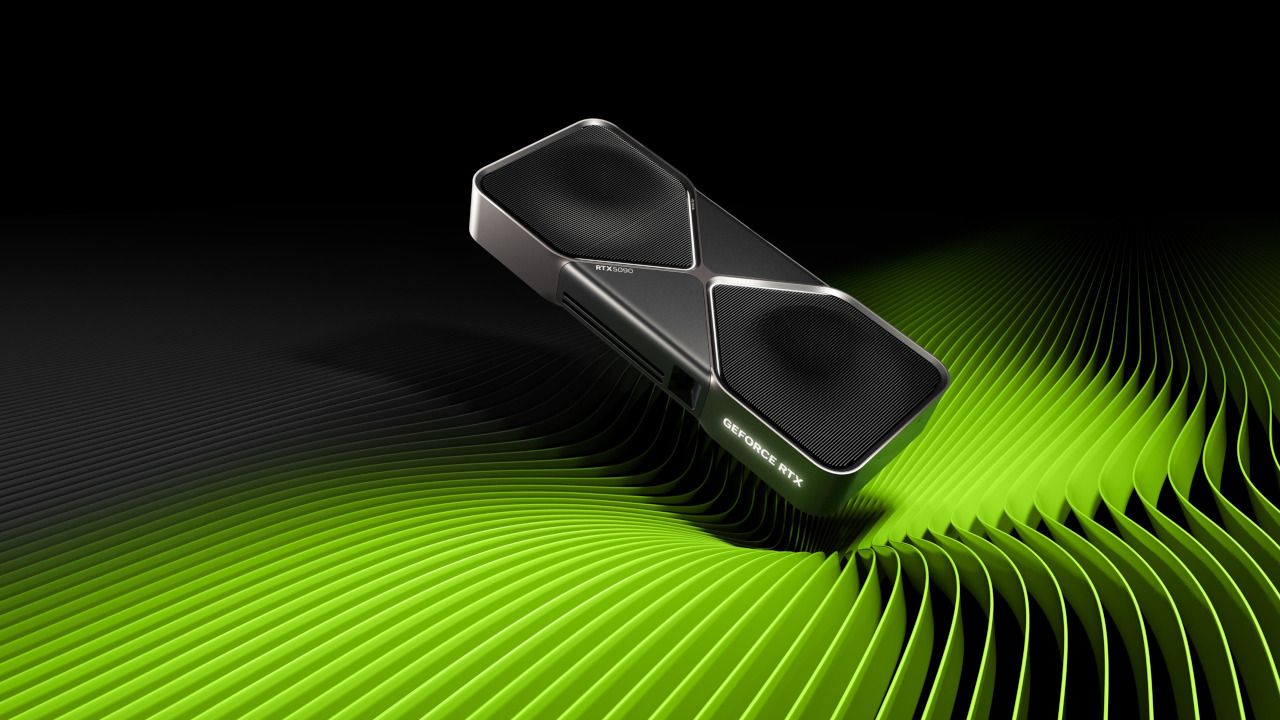

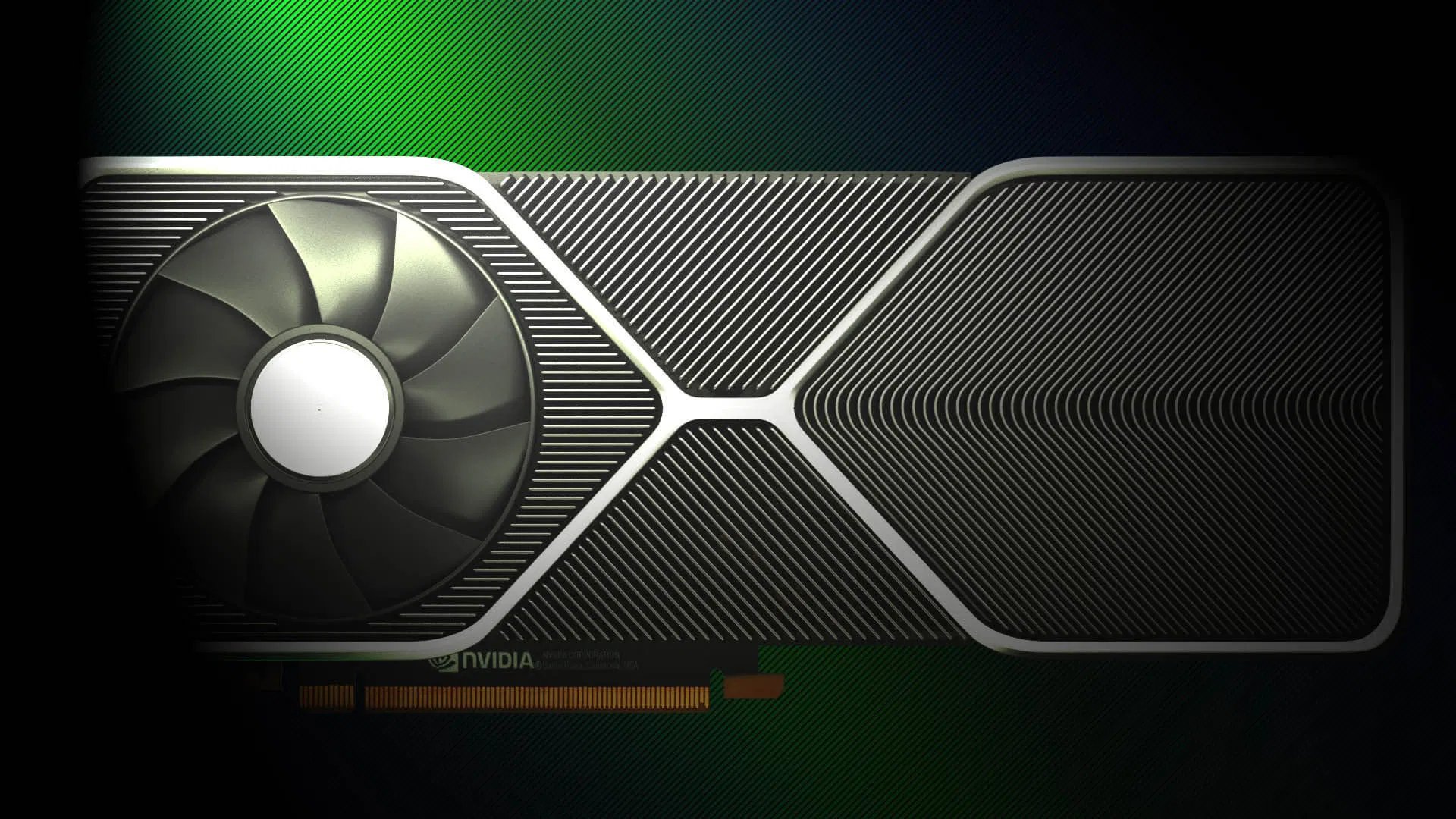

























![La guida allo sport in tv oggi [domenica 2 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)




