A tu per tu con Gerlinde Kaltenbrunner: “il mio alpinismo senza compromessi”
La fortissima austriaca si racconta, dalle prime gite con la parrocchia ai quattordici ottomila senza ossigeno: fiducia, desiderio e gestione della sofferenza alla base dei suoi successi L'articolo A tu per tu con Gerlinde Kaltenbrunner: “il mio alpinismo senza compromessi” proviene da Montagna.TV.

Classe 1970, Gerlinde Kaltenbrunner ha ancora il viso di una ragazzina, soprattutto quando sorride estasiata ai ricordi di un passato memorabile e difficile da riassumere in mezz’ora di intervista. «Sono grata per le opportunità che la vita mi ha dato» esordisce l’atleta Lowa, l’azienda che la supporta fin dal 2004. «Era il mio primo sponsor, anche se già indossavo spesso i loro scarponi, e mi è subito sembrato di entrare a far parte di una vera e propria famiglia». Il concetto di famiglia ritorna a più riprese, in barba a chi vorrebbe che la competizione invadesse totalmente anche il mondo alpinistico, lasciando poco spazio per la solidarietà e il piacere della condivisione. Ed è esattamente dalla distinzione fra questi due aspetti che la nostra chiacchierata prende il via.
Diventare la prima donna al mondo a scalare tutti gli ottomila senza ossigeno né portatori era un obiettivo quasi competitivo o soltanto la naturale evoluzione di un’avventura?
Per me la competizione non c’è mai stata. Amo l’alpinismo dal profondo del mio cuore e in amore non c’è posto per la competizione. Più che una gara era dunque un sogno. Un sogno di cime che hanno iniziato in maniera quasi naturale a mettersi in fila l’una dietro l’altra, arricchendo il mio palmarès. Soltanto dopo la nona vetta, il Kanchenjunga, ho capito che avrei potuto scalarle tutte e quattordici, cercando realmente questo primato. Ricordo anche il momento preciso: ero appena rientrata al campo base e sedevo su una pietra pensando a quanto sarebbe stato meraviglioso per me riuscire a farlo. Ma sempre in un clima di fatalismo generale. Quand’ero più giovane avevo gareggiato sugli sci e con la mountain bike e quella tensione agonistica la ricordavo molto bene perché poi l’ho rifuggita a tutti i costi: nel mio modo di affrontare la montagna non c’è mai stata. Certo, anche nell’ambiente alpinistico siamo costantemente tentati a metterci in competizione l’uno con l’altro, per via della forte pressione mediatica che preme su certe imprese, ma ho sempre cercato di scampare a questi meccanismi.
Pensi che Edurne Pasaban abbia invece ceduto alla competizione, utilizzando l’ossigeno supplementare per diventare la prima donna a salire tutti gli ottomila?
Credo non vi sia paragone, perché si tratta di imprese diversissime. La Pasaban è un’alpinista eccezionale, ma è evidente che utilizzare l’ossigeno sia qualcosa che ridimensiona la scalata stessa: una montagna di 8.000 metri raggiunta con questo genere di aiuto non è più alta 8.000 metri, perché non stai affrontando le condizioni di saturazione dell’aria che ci sarebbero a quelle quote. Si tratta sostanzialmente di abbassare la cima, che mentre la scali mantiene soltanto il suo nome, non la sua altezza. La prima volta che ho pensato all’Everest – la penultima vetta che ho raggiunto – mi sono ripromessa di non salirci, se non senza ossigeno. Per quanto fosse frustrante non completare il mio sogno, farlo in quel modo lo sarebbe stato ancora di più perché avrebbe significato che quella montagna era troppo alta per me, per il mio fisico e per la mia preparazione ed io ne avrei forzato la conquista nella maniera più sbagliata. Questo era chiaro fin dall’inizio per me: fin dal Broad Peak, il primo ottomila che ho salito, a 23 anni, nel 1994.
A tal proposito, tornando indietro alla tua giovinezza, quando hai cominciato a capire che l’alpinismo d’alta quota era la tua strada?
Ho iniziato ad avvicinarmi alla montagna grazie alle gite parrocchiali organizzate nel paese dal quale provengo. Si trattava di brevi escursioni, ma il prete che ci seguiva allora era molto “selvaggio” e con il suo benestare ci avvicinammo tutti all’arrampicata, così avventurosa e affascinante per noi. Più crescevo e più mi rendevo conto di come la montagna fosse frequentabile in così tanti modi, sia d’estate che d’inverno, e allora iniziai semplicemente a farlo: a frequentarla in tutti i modi. Finché, a 16 anni, assistei ad una conferenza sul K2 e da quel momento ne rimasi folgorata, iniziando a sognare quote sempre più elevate. Pensavo che almeno una volta nella mia vita avrei dovuto provare anche questo genere di alpinismo. Cominciai a cercare persone che volessero imbarcarsi in qualcosa di simile con me e con loro scegliemmo il Broad Peak, il più accessibile fra tutti gli ottomila, in termini di altezza e anche di difficoltà generali. Volevamo rompere il ghiaccio e per me fu l’avventura più importante della mia vita: mi sconvolse in positivo e fu allora che iniziai veramente a pensare di aver trovato il mio mondo.
Hai raccontato di aver iniziato ad arrampicare grazie ad un prete “visionario”: pensi che oggi sia difficile educare i bambini a qualcosa di simile?
Quand’ero piccola l’avventura era qualcosa a cui i nostri genitori ci sottoponevano volentieri: dai giochi per la strada alle prime scorribande in montagna. Penso sia una questione di fiducia: la fiducia nelle proprie abilità si costruisce da bambini, basandosi sulla fiducia che ci danno i nostri genitori. Abbiamo soppiantato la parola “fiducia” con il termine “sicurezza”, cercando di proteggere i nostri figli da qualsiasi pericolo, nella maniera più utopica e a mio avviso sbagliata possibile. Se i miei genitori non mi avessero permesso di avventurarmi, di frequentare le gite di cui ti parlavo prima, probabilmente non avrei mai scalato i quattordici ottomila ma non avrei nemmeno fatto in generale l’alpinista e trovato la mia dimensione fra quelle vette.
Ti saresti forse concentrata sulla tua professione d’infermiera, che comunque nei primi anni hai portato avanti parallelamente. Trovi analogie fra questo lavoro e l’alpinismo?
Senza dubbio. Per curare gli altri ci vuole dedizione ed è la stessa dedizione che per certi versi richiede una preparazione all’alpinismo d’alta quota. Più nella pratica, però, il mio mestiere mi è stato utile per affrontare gli infortuni durante una spedizione, ma ancora di più nel sapere come gestire un trauma, soprattutto a livello psicologico. Sai, lavoravo nel reparto oncologico e la morte era davvero il mio pane quotidiano. Non sapevo ancora che sarebbe stata così preponderante anche nelle mie imprese in montagna, specialmente nell’ultima vetta che mi mancava, il K2 .
Proprio sulla parete sud del K2 hai perso due amici: Fredrik Ericsson nel 2010 e Michele Fait l’anno precedente. Dove hai trovato la tenacia necessaria a non demordere e raggiungerne la vetta, nel 2011?Espressamente da loro. Sul K2 ho fatto in totale quattro spedizioni, con due tentativi per ciascuna, e ogni volta qualcosa di mostruoso accadeva. Sicuramente la morte di Fredrik e di Michele, ma anche quella di Cristina Castagna, precipitata dal Broad Peak sempre nel 2009, con cui avevamo condiviso molto tempo al campo base, legando tanto. Furono perdite che mi segnarono moltissimo, tant’è che per un periodo pensai quasi che il K2 non mi volesse. Però la motivazione non se ne andava: si era di certo affievolita, ma era sempre lì. E l’idea di aver condiviso così tanti ricordi, bellissimi e tremendi insieme, sulla parete sud mi fece propendere per tentare invece, nell’ultima spedizione, la nord. Tutti i media mi schernirono, ma non solo loro: anche la mia famiglia e i miei amici pensarono che fossi impazzita. Non riuscire per la via più facile e scegliere la più difficile sembrava assurdo. Eppure era quello che mi sentivo chiamata a fare, per rispetto verso tutto quanto era accaduto sull’altro versante, dove non volevo più tornare, per nessun motivo al mondo. E vi furono momenti incredibili, durante quella salita alla nord, in cui veramente mi sembrava di avere tutti loro accanto a me. Arrivare su quella cima fu il momento più bello della mia vita, mi emoziono ancora quando ne parlo.
Quattordici anni dopo quell’istante straordinario, quali altri desideri può avere Gerlinde Kaltenbrunner? Cosa ti aspetti dal futuro?
Sicuramente continuare nei progetti che seguo con l’associazione Nepalhilfe Beilngries. Soprattutto la costruzione di edifici scolastici e l’invio di aiuti umanitari. Poi frequento ancora l’Himalaya e il Karakorum, ponendomi come obiettivi vette più abbordabili, sui 7.000 metri, ma sempre molto interessanti. Mi piace il modo in cui, negli ultimi anni, sto tornando a frequentare la montagna come facevo all’inizio: sci ai piedi o imbrago in vita, per il semplice gusto di starci. E starci bene.
L'articolo A tu per tu con Gerlinde Kaltenbrunner: “il mio alpinismo senza compromessi” proviene da Montagna.TV.











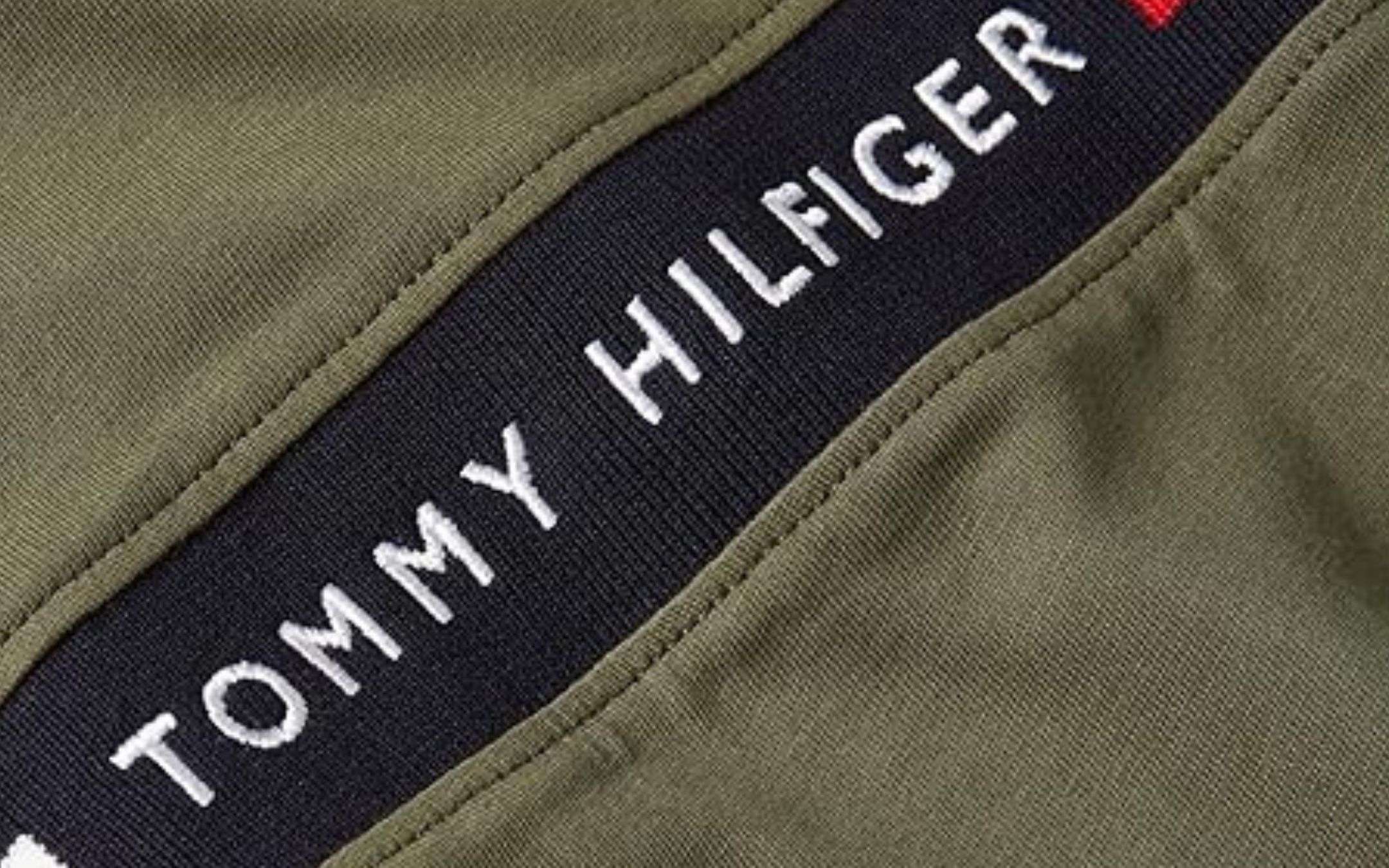





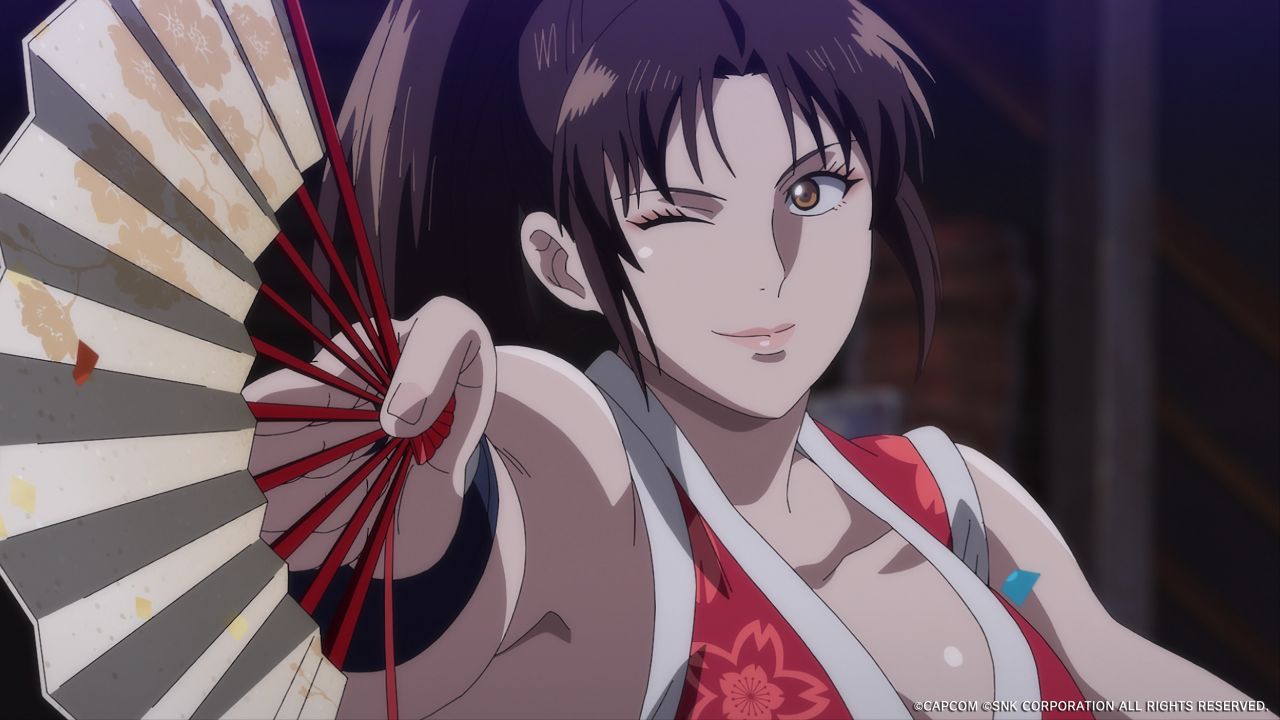






















![La guida allo sport in tv oggi [martedì 4 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/teleco.jpg)


/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/03/4094084-83019344-310-310.jpg)











