Come noto la questione sulla esecutività o meno dei mutui c.d. “condizionati” è all’esame della SS.UU. dopo l’arresto provocato dalla sentenza n. 12007/2024 della S.C. per la quale “la banca avrebbe dovuto accertare se lo svincolo, in favore della parte mutuataria della somma già a questa concessa in mutuo e poi ritrasferita nella disponibilità della banca mutuante, risultasse documentata con un ulteriore atto pubblico o una ulteriore scrittura privata autenticata, come richiesto dall’art. 474 c.p.c..Ciò in quanto, per avere valore di titolo esecutivo, l’atto pubblico notarile di cui si discute, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza -in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.- attestante l’avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato”.
In realtà questo principio è tutt’altro che nuovo, in quanto anche in Cass. 17194/20015 e 6174/2020 è richiesto che l’erogazione risulti da un atto “idoneo”: “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.
La S.C. non parla semplicemente semplicemente di “forma scritta”, in quanto normalmente anche gli atti di quietanza sottoscritti con scrittura privata soddisfano il requisito: la S.C. richiede che in caso di mutuo condizionato l’atto di erogazione e quietanza, affinchè il mutuo possa essere titolo esecutivo, abbia la forma dell’atto pubblico, nel quale si dia atto della definitiva consegna delle somme mutuate perché quello che conta al fine del riconoscimento dell’esecutività di un atto è la certezza che in virtu’ di esso siano state consegnate somme ratio che giustifica l’obbligo di restituzione.
La ragione di questa decisione – ben conosciuta dallo scrivente avendo seguito la causa- è l’aver offerto una visuale prospettica chiara ed innovativa della fattispecie, a seguito della quale la Corte ha approfondito ulteriormente il tema della disponibilità delle somme: una volta dimostrato che le somme mutuate siano effettivamente erogate al momento dell’atto queste legittimamente possono essere costituite dal mutuatario in un deposito irregolare presso la banca, ma in questo modo ex art. 1834 cc la banca stessa ne diviene proprietaria confondendosi il denaro depositato con quello già di proprietà della banca, la quale a seguito del deposito diviene proprietaria del denaro e si obbliga solo a consegnare una somma pari alla somma depositata una volta che si siano avverate le condizioni.
Come nel “gioco dell’oca” si torna quindi alla casella iniziale:
- La banca consegna denaro al mutuante al momento della stipula;
- Il mutuante riconsegna la somma di denaro alla banca e lo costituisce in deposito irregolare ma in tal modo la somma torna non solo nella disponibilità ma nella proprietà della banca;
- La banca quindi non si priva della proprietà del denaro ma semplicemente mediante il deposito assume l’obbligazione di consegnarlo una volta che si avveri una o piu’ condizioni previste in contratto.
Quindi mediante la stipula di un atto condizionato, con contestuale costituzione di deposito in favore della banca mutuante, non per una forzatura dello scrivente ma applicando le norme del codice civile, le somme mutuate tornano di proprietà della banca la quale assume solo un’obbligazione restitutoria.
Se non è provato che il deposito sia cessato e quindi che la somma sia restituita questa non entra nuovamente nella proprietà del mutuatario che è titolare solo di un diritto alla consegna peraltro condizionato ad un evento futuro ed incerto.
Se la consegna non è provata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata il mutuatario non assume nessun obbligo di restituire alcunchè, compresi gli interessi che decorrono normalmente dall’effettiva messa a disposizione delle somme a seguito dell’avveramento delle condizioni.
Bisogna quindi applicare l’art. 1813 “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”; l’ art. 1814 c.c.“ Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario”; l’ art. 1782 c.c. “Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo” e l’art. 1834 c.c. per il quale “Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto”.
E’ il codice stesso, nella sua semplicità e “perfezione” ad equiparare mutuo e deposito irregolare, al quale sono applicabili le norme del mutuo tanto che anch’esso comporta il trasferimento della proprietà del denaro.
Quindi, se anche si dovesse ritenere che mediante un mutuo condizionato sia avvenuto un passaggio di denaro, seppur dematerializzato, al momento della stipula la contestuale costituzione delle somme in deposito comporta un inverso trasferimento dal mutuatario alla banca delle somme mutuate, per cui anche per questo assorbente motivo gli atti condizionati non possono essere titolo esecutivo, in quanto non sono atti reali ma obbligatori, in quanto le somme tornano immediatamente in proprietà della banca la quale si obbliga solo a consegnarle una volta che si avveri una condizione, e per tale assorbente ragione i contratti c.d. “condizionati” non possono essere di per se titoli esecutivi.
Nella pratica è poi frequente riscontrare che in realtà al momento della stipula non avvenga alcun trasferimento di denaro, seppur dematerializzato, dalla banca al mutuatario, ne in senso contrario il denaro venga restituito sotto forma di deposito irregolare.
In questi casi senza alcun dubbio non ci può parlare di titolo esecutivo.
Primo problema da risolvere è capire che valore abbia la dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto le somme erogate dalla banca.
Per l’art. 2700 cc “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti“.
Per Cass. 20520/2020 “L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il -pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto- non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”, cio’ conformemente a SS. UU. n. 19888/2014 per le quali “La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 cod. civ., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero”. Dovendo la consegna delle somme essere contestuale al contratto di mutuo, e dovendosi presumere per le ragioni di cui sopra che la consegna non sia avvenuta per contanti, né che la banca abbia dato prova di aver effettuato una disposizione elettronica delle stesse, è da ritenersi provato che il mutuatario, nel momento in cui dichiara di aver ricevuto la somma mutuata, compie un vero e proprio “atto di fede” non avendone alcuna contezza, quindi la quietanza è contestabile a posteriori in base a SS.UU. n. 19888/2014 per errore di fatto, in quanto rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero.
Il mutuatario puo’ quindi agire in giudizio per far accertare e dichiarare che la quietanza rilasciata a suo tempo sia stata prestata in assenza di alcun elemento oggettivo che comprovasse l’effettivo trasferimento di somme a suo favore, non potendo avvenire in contanti e non avendo la banca esibito una contabile di disposizione elettronica delle somme mutuate.
E’ quindi possibile contestare la quietanza contenuta nell’atto di mutuo, tanto piu’ se è provato che l’erogazione non sia stata contestuale alla stipula dell’atto notarile, ed in tal caso il Giudice dell’Esecuzione dovrebbe, a parere dello scrivente anche d’Ufficio in ossequio a Cass. n. 22430/2004 e n. 2043/2017– richiedere alla banca il deposito della contabile mediante la quale al momento dell’atto è avvenuto il trasferimento delle somme a favore della mutuataria, nonché di quella mediante il quale dette somme sono state riconsegnate alla banca a titolo di deposito irregolare e di quella mediante è avvenuto il definitivo trasferimento a favore della mutuataria.
Se dovesse risultare provato questo doppio trasferimento nulla questio, si tornerebbe alle considerazioni che precedono per cui si potrebbe solo disquisire che il mutuo condizionato con contestuale costituzione di un deposito irregolare sia un contratto reale o solamente obbligatorio.
Ma se dovesse risultare confermato che il giorno dell’atto non sia avvenuto alcun trasferimento a favore della mutuataria solo per questa assorbente ragione il mutuo in esame non potrebbe essere ritenuto titolo esecutivo.












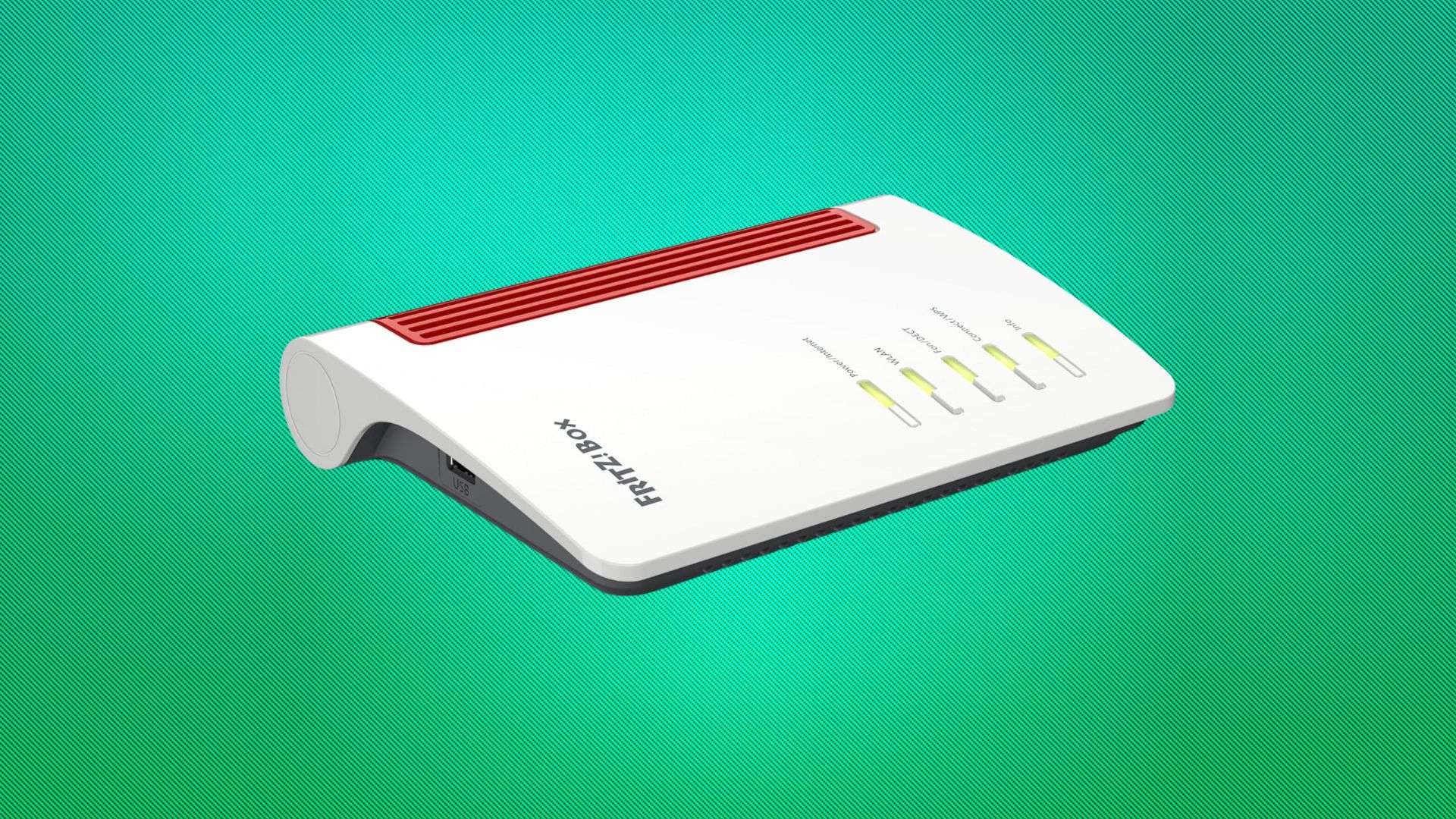










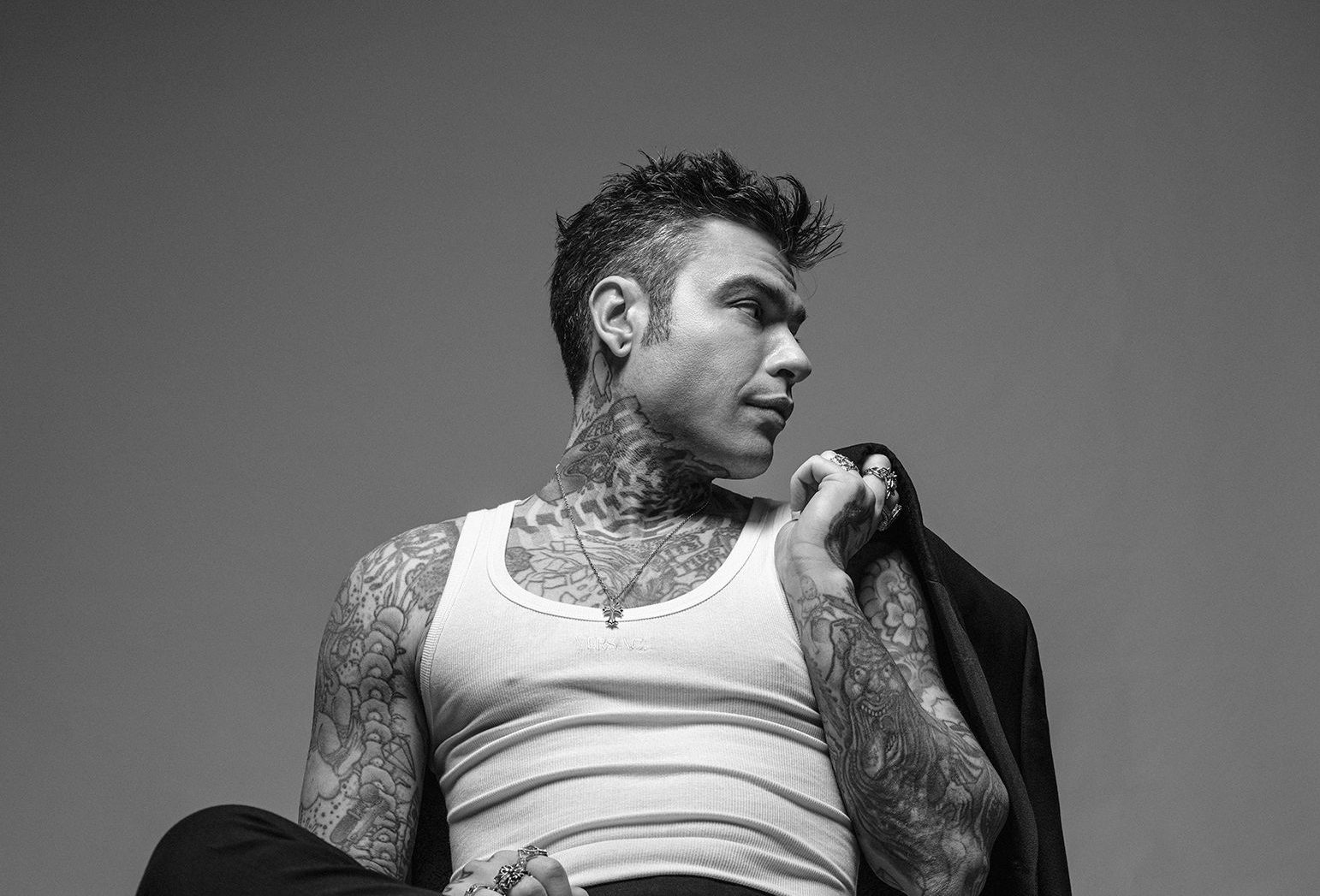





















/origin-imgresizer.eurosport.com/2025/02/07/4095275-83043164-310-310.png)




 Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Iscriviti alla nostra newsletter settimanale


