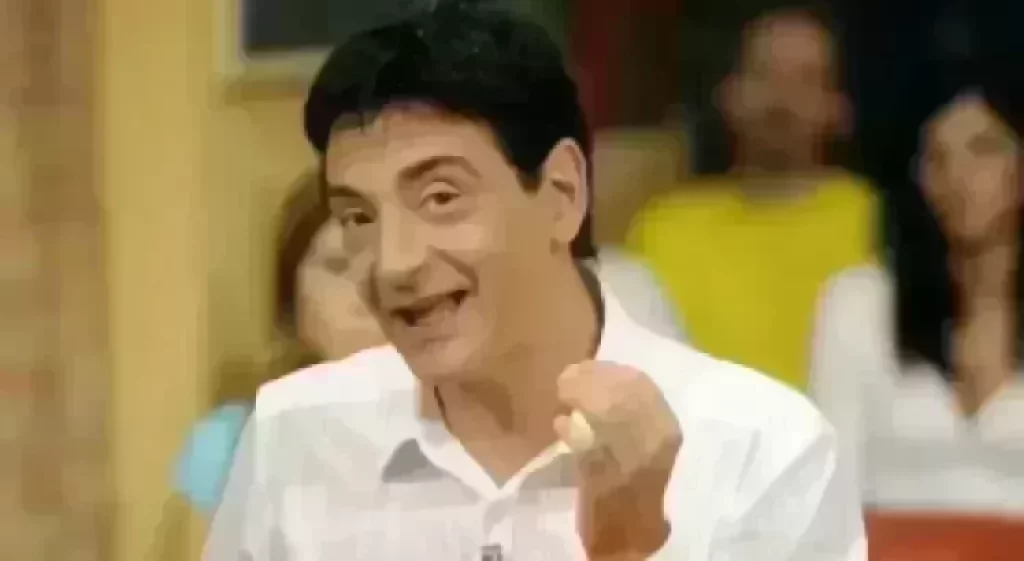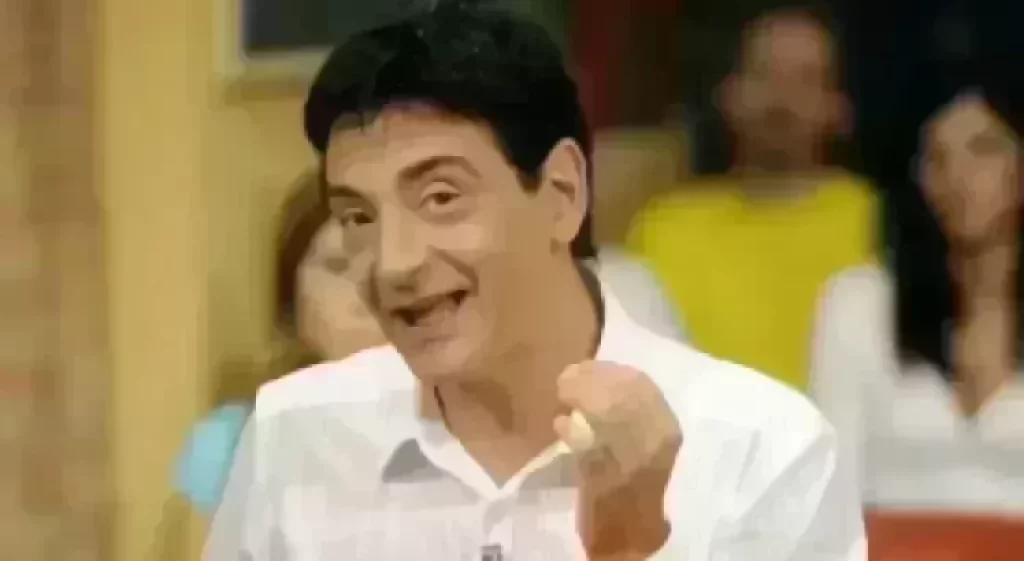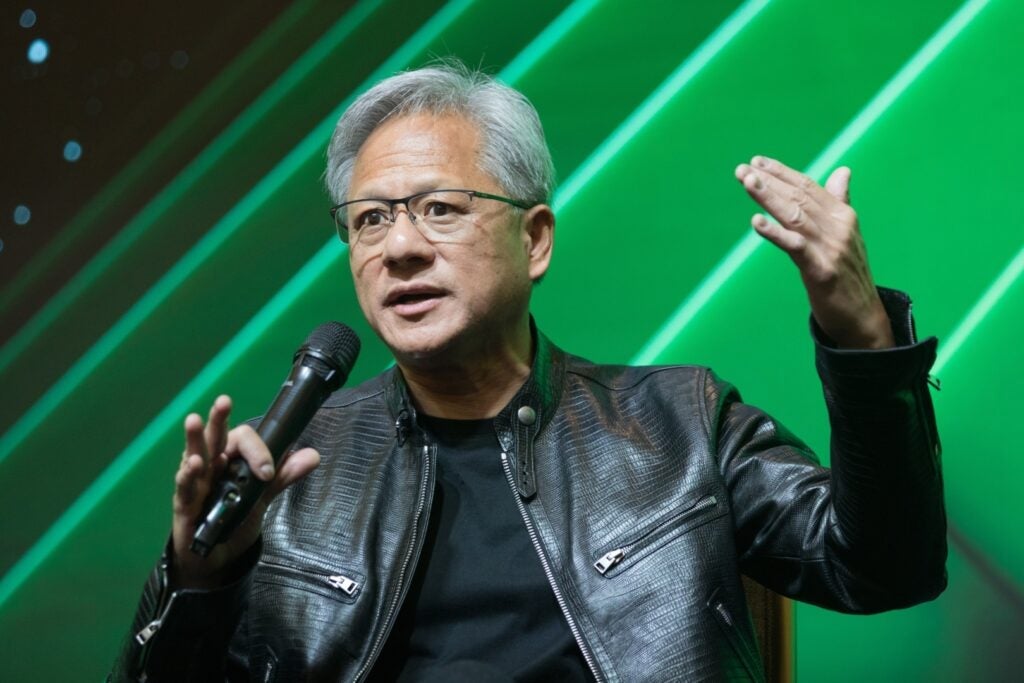La riduzione del danno: dai rave ai club
Prefazione Parkett Channel e SUM (Sound Underground Music) desiderano chiarire che non promuovono in alcun modo l’uso di sostanze. Il nostro impegno è volto a favorire una comunicazione consapevole e una corretta informazione sui temi legati alla cultura clubbing, alla musica elettronica e al benessere delle persone che vi partecipano e che la vivono. La […] L'articolo La riduzione del danno: dai rave ai club sembra essere il primo su Parkett.

Prefazione
Parkett Channel e SUM (Sound Underground Music) desiderano chiarire che non promuovono in alcun modo l’uso di sostanze. Il nostro impegno è volto a favorire una comunicazione consapevole e una corretta informazione sui temi legati alla cultura clubbing, alla musica elettronica e al benessere delle persone che vi partecipano e che la vivono.
La nostra attenzione alla riduzione del danno e alla limitazione dei rischi non vuole incoraggiare il consumo di sostanze, ma mira a offrire strumenti di consapevolezza e di tutela della salute per chi, consapevolmente o meno, si trova a confrontarsi con questi mondi. Crediamo che una comunicazione chiara e basata su informazioni corrette sia fondamentale per proteggere la salute e la sicurezza degli individui, nel rispetto dei diritti di ciascuno.
La nostra missione è di sensibilizzare il pubblico verso l’importanza della prevenzione, del rispetto reciproco e della promozione di ambienti sicuri, attraverso l’informazione e la collaborazione con realtà come Neutravel, che lavorano attivamente sul campo per minimizzare i rischi legati a questi contesti.
Introduzione
In questo editoriale, scritto in collaborazione con SUM (Sound Underground Music) e Neutravel, servizio finanziato dalla Regione Piemonte e gestito come servizio pubblico da ASL TO4, esploriamo il tema cruciale della riduzione del danno e limitazione dei rischi all’interno della scena clubbing e dei festival in Italia. Attraverso un’intervista approfondita con NTV, realtà impegnata da anni in questo campo, cercheremo di capire come l’informazione e la prevenzione possano contribuire a rendere più sicuri questi ambienti, spesso associati all’uso di sostanze.
SUM è una piattaforma che promuove la cultura underground musicale e crea uno spazio di dialogo e condivisione per chi vive il mondo free tekno e la musica elettronica come espressione artistica e comunitaria. Insieme a SUM e Neutravel, noi di Parkett abbiamo voluto unire le forze per raccontare storie e approcci legati alla sicurezza, alla salute e alla consapevolezza in questi contesti, offrendo un punto di vista informato su come stanno cambiando le dinamiche del divertimento, del consumo e delle misure preventive nel nostro Paese.
Cosa sono La RdD e LdR?
La Riduzione del Danno (RdD)e la Limitazione dei Rischi (LDR) sono nate dalla consapevolezza che non tutte le persone che fanno uso di sostanze psicoattive necessitano di trattamenti o cure mediche specifiche. La maggior parte dei consumatori, infatti, non sviluppa dipendenze patologiche o problemi di salute gravi, ma continua a fare uso di sostanze in vari contesti, come eventi sociali e situazioni di svago. Questo ci porta alla necessità di offrire loro informazioni e strumenti per ridurre i rischi correlati al consumo.
Mirano a minimizzare i danni a cui queste persone possono andare incontro, attraverso interventi che li aiutino a proteggere sé stessi e gli altri, a evitare situazioni di pericolo e a rimanere in buona salute. Un approccio che considera le persone come individui in possesso di diritti, la cui dignità e benessere devono essere rispettati e preservati, senza giudizi morali o imposizioni di astinenza.
La strategia di RdD/LdR si articola su due principali ambiti:
1. Riduzione dei Danni: si concentra su chi utilizza sostanze psicoattive, sia legali che illegali, cercando di limitare i danni sanitari, sociali e giudiziari, senza escludere l’idea di una possibile riduzione del consumo futuro.
2. Limitazione dei Rischi: rivolta a coloro che non hanno ancora sviluppato problematiche significative legate al consumo, ma necessitano comunque di protezione per prevenire effetti negativi sul piano fisico, psicologico e sociale.
La battaglia chiave quindi della Riduzione del Danno riguarda i diritti umani. Spesso, politiche repressive in materia di sostanze stupefacenti creano un ambiente che amplifica i rischi per i consumatori, criminalizzandoli o negando loro accesso a cure e servizi di supporto. Ed è in questo contesto che la RDD si pone come un baluardo di difesa per quei diritti spesso calpestati.
L’evoluzione delle droghe e degli stili di consumo richiede interventi sempre più complessi e adattivi, che possano comprendere la diversificazione delle pratiche, dai consumi occasionali e sperimentali alle situazioni più estreme come quelle vissute da chi cerca rifugio nell’uso di sostanze in risposta a situazioni di marginalità sociale e malessere psicologico.
L’importanza della prossimità è centrale in questi interventi: stare vicini alle persone e ai loro bisogni, senza stigmatizzarle, attraverso un lavoro di squadra tra istituzioni sanitarie, sociali e educative.
Gli Anni ’70 e Le Prime Avvisaglie di Cambiamento
La riduzione del danno (RDD) rappresenta uno dei pilastri più innovativi e controversi delle politiche di salute pubblica legate al consumo di sostanze. Mentre nel contesto della “war on drugs” lanciata negli Stati Uniti negli anni ’70, il clima era dominato dalla tolleranza zero e dalla repressione, in Europa, si stava sviluppando un pensiero alternativo. In Paesi come l’Olanda e la Svizzera, l’approccio repressivo veniva affiancato da una crescente attenzione ai diritti umani e al benessere delle persone tossicodipendenti. Si cominciava a mettere in discussione l’efficacia del solo deterrente penale, e si iniziava a esplorare l’idea che ridurre i danni correlati all’uso di sostanze potesse avere un impatto maggiore sulla salute pubblica.
È in questi anni che emerge il concetto fondamentale della riduzione del danno: l’obiettivo non è necessariamente eliminare il consumo di sostanze, ma ridurre i rischi associati, come la trasmissione di malattie infettive, overdose, e marginalizzazione sociale.
Gli Anni ’80 e L’HIV : l’Urgenza di Nuove Strategie
Gli anni ’80 furono segnati da una tragedia sanitaria globale: l’emergenza dell’epidemia di HIV/AIDS. La diffusione del virus tra i consumatori di sostanze iniettive, a causa dello scambio di siringhe contaminate, diede una spinta decisiva allo sviluppo della riduzione del danno. In Europa, in particolare nel Regno Unito, si iniziò a vedere la distribuzione di siringhe pulite e il trattamento con metadone come misure vitali per limitare i danni.
L’Olanda fu pioniera con l’apertura di stanze del consumo sicuro, dove le persone potevano usare sostanze sotto la supervisione di personale sanitario. Queste iniziative non avevano come obiettivo la prevenzione del consumo, ma la riduzione delle conseguenze letali.
Gli Anni ’90: La Maturazione
Negli anni ’90, la riduzione del danno si consolidò come una strategia globale. Il successo delle prime politiche di RDD nei Paesi europei portò ad una loro espansione. Le Nazioni Unite iniziarono a riconoscere ufficialmente l’importanza di approcci diversi dal solo proibizionismo, e organizzazioni internazionali come l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) promuovevano attivamente la RDD come strategia di salute pubblica.
La Svizzera e la Germania furono tra i primi Paesi ad avviare programmi di distribuzione controllata di eroina, un’iniziativa che, in controtendenza rispetto al pensiero comune, dimostrò di ridurre in modo significativo i decessi per overdose e i crimini legati all’acquisto della sostanza. I dati provenienti da queste esperienze influenzarono profondamente le politiche sanitarie di molti Paesi, ponendo le basi per un cambiamento globale nel trattamento della tossicodipendenza.
L’Italia e il Ritardo nell’Integrazione della Riduzione del Danno
L’Italia, rispetto ad altri Paesi europei, ha avuto un percorso più lento e accidentato nell’adozione di politiche di riduzione del danno. Negli anni ’90, l’Italia era ancora fortemente ancorata a un approccio proibizionista, sostenuto dalla Legge Jervolino-Vassalli (1990), che equiparava il consumo di droghe pesanti e leggere e promuoveva un approccio punitivo.
Torino ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dei progetti e dei servizi di riduzione del danno in Italia. Uno degli esempi più noti è Can Go, un servizio mobile nato come autobus itinerante per distribuire siringhe e materiale sterile nelle principali “scene aperte di consumo” della città. Oggi, Can Go ha una postazione fissa vicino alla storica area di consumo di Porta Palazzo, precisamente in Corso Giulio 15. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, dalle 10:00 alle 14:00, e ogni primo sabato del mese collabora con Neutravel per offrire il servizio di drug checking, fondamentale per la sicurezza dei consumatori.
Un altro esempio importante è l’associazione Isola di Arran, fondata negli anni ’90 da persone che usano sostanze. L’associazione ha dato vita a una rete di “operatori pari“, persone con esperienza diretta che collaborano nei servizi pubblici per le dipendenze, apportando un prezioso approccio basato sulla condivisione di esperienze personali.
Tra i pionieri della riduzione del danno a Torino e promotori dell’approccio in Italia vi sono state Susanna Ronconi e Maria Teresa Ninni, il cui lavoro ha dato impulso a nuove prospettive e pratiche di assistenza e riduzione dei rischi per le persone che usano sostanze.
Nonostante questo però questi progetti pionieristici rimanevano marginali e scarsamente finanziati rispetto alle strategie dominanti.
Solo negli anni 2000, con l’aumento della pressione da parte delle organizzazioni non governative e la diffusione di buone pratiche europee, l’Italia ha cominciato a riconoscere ufficialmente la riduzione del danno come una parte del sistema di welfare legato alla tossicodipendenza.
Neutravel
La prima edizione del progetto Neutravel si è ispirato ad esperienze italiane come Extreme a Firenze e Nautilus a Roma, nonché a diverse reti europee impegnate nello sviluppo della riduzione del danno nei contesti del divertimento.Tra queste si annoverano Safer Party di Zurigo, Energy Control a Barcellona, CHECK!N in Portogallo e Jellinek in Olanda.
Negli anni 2000, il principale network europeo che raggruppava organizzazioni attive nella riduzione del danno e nel limitare i rischi legati al consumo di sostanze nei contesti del divertimento era il Correlation Network, oggi noto come Correlation European Harm Reduction Network.
Dal Correlation Network è stato successivamente istituito il NEWNet, una rete europea attuale che raccoglie le principali organizzazioni impegnate in interventi e servizi nel contesto dei party setting. All’interno di NEWNet opera TEDI, che riunisce le principali organizzazioni europee che offrono servizi di drug checking. TEDI condivide ogni anno i dati raccolti con EUDA (European Union Drugs Agency).
Questa rete di collaborazioni internazionali consente uno scambio costante di informazioni e buone pratiche, facilitando un approccio coordinato alla riduzione del danno in Europa.
Di recente presenti al C2C di Torino, uno degli eventi di musica elettronica più grandi d’Italia, NTV e PIN hanno sviluppato uno spazio sicuro e informato, dove i partecipanti possono ottenere informazioni sull’uso sicuro delle sostanze, ricevere consulenze da parte di operatori specializzati e accedere a kit di prevenzione. Questi includono, ad esempio, tappi per le orecchie, informazioni su idratazione e riposo, e consulenze individuali per chi sta vivendo situazioni di disagio psicologico o fisico durante l’evento.
La prevenzione delle overdose, la tutela del benessere psicofisico e la promozione di un consumo più consapevole sono al centro del lavoro di Neutravel, che cerca di integrare i valori della riduzione del danno nel cuore della cultura festiva giovanile.
Questa prospettiva ci porta a domandarci: quali sono le sfide che oggi, a fronte di cambiamenti sociali e culturali come quelli provocati dal COVID-19, i progetti di Riduzione del Danno devono affrontare? Come è cambiata la scena del consumo di sostanze nei contesti festivi e nei club post-pandemia? E soprattutto, che risposte stanno dando oggi le politiche pubbliche italiane rispetto a questo approccio tanto cruciale quanto spesso trascurato?
Ne abbiamo parlato con Ilaria Fineschi Piccinin e Diletta Polleri, professioniste del progetto Neutravel.
Come è nato il progetto Neutravel e quali sono stati i principali ostacoli che avete dovuto affrontare per portare la riduzione del danno nei contesti dei festival e dei club italiani?
Diletta: Non ero presente alla nascita di Neutravel, poiché ho iniziato a collaborare nel 2017, ma il progetto è nato all’interno dei contesti del divertimento, in particolare nei free party, e successivamente si è esteso al mondo delle feste legali.
Uno dei principali ostacoli che ricordo dalla mia esperienza è stato far capire agli organizzatori di eventi notturni e festival che la riduzione del danno non rappresentava un’ammissione del consumo di sostanze nei loro eventi. Al contrario, si trattava di offrire un servizio di tutela della salute per i partecipanti, un valore aggiunto di cui potevano andare fieri. Inizialmente, molti erano spaventati, temendo che la presenza di questi servizi potesse sembrare una sorta di autodenuncia.
Ma posso dire che negli anni ho visto un cambiamento significativo in questo atteggiamento. Oggi, molti gestori di locali e organizzatori di eventi comprendono il valore della riduzione del danno, non solo in termini di salute, ma anche come elemento positivo per la comunicazione e l’immagine politica del loro contesto di divertimento. Dimostrare attenzione per la salute e i diritti dei frequentatori è diventato un segno di responsabilità e cura.
Ilaria: Questo cambiamento non è avvenuto rapidamente; ci sono voluti circa dieci anni per arrivare a questa consapevolezza. Credo che anche il periodo post-Covid abbia accelerato questo processo, complice il contesto di restrizioni governative sui free party. Le difficoltà di quel periodo hanno spinto molte realtà a riconsiderare l’importanza della salute e della sicurezza nei loro eventi.
Come si è evoluta la vostra presenza nel circuito dei festival più istituzionali come il Kappa FuturFestival?
Negli ultimi anni, il mondo ha vissuto cambiamenti senza precedenti a causa della pandemia di COVID-19, che ha forzato la maggior parte delle interazioni sociali a un arresto temporaneo. Mentre il mondo cerca di riprendersi e di tornare alla normalità, molti giovani, che durante quel periodo buio erano in fase di sviluppo e socializzazione, si stanno nuovamente avventurando nel panorama delle feste e dei club. Nonostante ciò, ci si domanda se le esperienze vissute durante il lockdown abbiano influenzato il loro approccio alle sostanze e al divertimento.
Infatti, come la pandemia ha influenzato l’attenzione verso la tutela della salute e la percezione della prevenzione e della riduzione del danno?
La pandemia ha certamente spostato l’attenzione su molteplici sfaccettature. Si è compreso che la prevenzione è una parte fondamentale della tutela della salute, non un elemento separato o secondario. La pandemia ha reso evidente come prevenzione e riduzione del danno siano strategie complementari, che lavorano insieme per proteggere la salute delle persone.
Complici le difficoltà legate alle ordinanze municipali contro la movida, come le restrizioni sull’uso del vetro e sugli orari di apertura, che hanno spinto i gestori di locali e gli organizzatori di festival a cercare nuove strategie per continuare le loro attività. Aprirsi alla riduzione del danno è stata una di queste strategie, diventando una risorsa importante per garantire la sicurezza e il benessere del pubblico.
Avete notato cambiamenti significativi nel comportamento dei giovani?
Durante e subito dopo la pandemia, abbiamo partecipato a vari studi e interviste qualitative per analizzare l’uso di sostanze durante quel periodo. Uno di questi studi si concentrava sull’uso di alcol e altre sostanze durante la pandemia, cercando di capire quali sostanze fossero più accessibili e come le persone si autoregolassero. Abbiamo scoperto che molti, non solo giovani, hanno aumentato il consumo di alcol e farmaci, in parte perché queste sostanze erano più facilmente reperibili.
Il lockdown ha reso complicato procurarsi sostanze, quindi molti si sono rivolti a ciò che era disponibile in casa. Questo ha portato a un aumento dell’uso ricreativo o off-label di farmaci, un fenomeno che in parte persiste ancora oggi.
Non si può dire che ci sia stato un aumento uniforme del consumo di sostanze; piuttosto, il comportamento è cambiato in base alla disponibilità. Durante il lockdown, la difficoltà di accesso a determinate droghe ha portato molte persone a fare uso di alcol o farmaci disponibili in casa. Questo comportamento ha lasciato un’impronta anche nel periodo post-pandemia, con un uso ricreativo di farmaci decisamente più diffuso rispetto a qualche anno fa.
Quindi c’è un pre e un post pandemia se si parla di consumo?
Più che un semplice confronto pre e post-pandemia, penso che il fattore determinante sia legato all’età e all’accessibilità delle informazioni. Oggi i giovani hanno strumenti migliori per accedere a informazioni affidabili sulle sostanze rispetto alle generazioni precedenti, grazie all’evoluzione di internet e alla disponibilità di fonti sicure. Questo ha creato una generazione più consapevole rispetto ai rischi e alle modalità di consumo, anche grazie a progetti come il nostro che facilitano l’accesso a queste risorse.
Qual è stato l’impatto sui trend attuali di consumo e sulla scena dei rave e dei club?
Gli effetti della pandemia sono ancora visibili, ma è difficile tracciare una linea chiara su cosa sia cambiato esclusivamente a causa di essa. Ci sono anche dinamiche di mercato che influenzano l’uso delle sostanze, indipendenti dal contesto pandemico. Un aspetto interessante è la mancanza di un passaggio di consegne tra le vecchie e nuove generazioni di organizzatori di rave e feste. Ma i giovani di oggi, nonostante questa discontinuità, mostrano una maggiore consapevolezza e spesso ci chiedono direttamente interventi di riduzione del danno. Questo dimostra che, nonostante tutto, si stanno ottenendo risultati positivi.
Avete notato un cambiamento nelle abitudini di consumo di alcol tra le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti?
Assolutamente sì, e una cosa che ci colpisce sempre è ciò che emerge dai dati raccolti tramite l’etilometro. Quando facciamo i test alcolici, vediamo che i giovani hanno già pensato a strategie per tornare a casa in sicurezza, come avere un amico sobrio, prendere un taxi o usare la bici. Questo è un comportamento che non si riscontra spesso tra i 30-40enni, che sembrano meno attenti a queste misure di sicurezza.
Pensate che questo cambiamento sia legato a un maggiore accesso alle informazioni?
Sì, sicuramente. Le nuove generazioni hanno accesso a una vasta mole di informazioni e progetti come i nostri aiutano a diffondere consapevolezza. Questo ha portato a un consumo più consapevole, soprattutto di alcol e cannabis. Tuttavia, non abbiamo dati epidemiologici precisi per confermare un trend generale, anche se vediamo cambiamenti significativi nel nostro osservatorio.
Quindi, in generale, pensate che i giovani consumino meno o più consapevolmente rispetto al passato?
Non possiamo fare generalizzazioni senza dati solidi. Ci sono molte variabili in gioco, come l’area geografica e il livello di marginalità, quindi è difficile trarre conclusioni definitive senza un’analisi epidemiologica più approfondita.
Ci potete raccontare qualche episodio in cui la vostra presenza ha prevenuto situazioni critiche o addirittura salvato vite?
Diletta: Un episodio significativo che ci viene in mente è avvenuto durante una Street Parade, penso fosse nel 2022. Era un evento del movimento Free Party, organizzato in risposta al decreto anti-rave. Noi siamo stati contattati dagli organizzatori per portare il nostro intervento mobile, trasformato in un’area chill-out dove le persone potevano riprendersi se non si sentivano bene, sempre con la presenza di operatori.
Verso la fine del corteo, quando la situazione sembrava ormai tranquilla, ci è stato segnalato un caso di overdose. La persona era in condizioni critiche e abbiamo somministrato diverse dosi di Narcan (almeno tre o quattro) in attesa dell’ambulanza, che purtroppo è arrivata dopo circa 40 minuti, nonostante fossimo relativamente vicini a un ospedale. La mancanza di un presidio sanitario adeguato in eventi del genere è un problema serio, e in questo caso, la nostra presenza è stata cruciale: senza il nostro intervento, quella persona probabilmente non ce l’avrebbe fatta.
Ilaria: Un altro episodio che vorremmo condividere riguarda il supporto offerto durante festival legali o serate. Spesso interveniamo per aiutare persone in difficoltà dopo aver assunto grosse quantità di sostanze come MDMA o ketamina. In molti casi, grazie al nostro intervento, queste persone riescono a riprendersi senza dover essere portate in ospedale. Evitiamo così che vengano esposte a un ambiente ospedaliero potenzialmente stressante e lontano dal loro contesto sociale. Offrire supporto diretto sul posto non solo aiuta a garantire il benessere delle persone coinvolte, ma contribuisce anche a evitare sovraccarichi inutili per il sistema sanitario.
Quanto pesa ancora la cultura del proibizionismo nelle scelte politiche italiane, e quali misure concrete potrebbero migliorare il lavoro nel settore della riduzione del danno?
È innegabile che l’Italia, come gran parte dell’Europa, sia ancora influenzata da una cultura proibizionista, evidente nelle recenti decisioni governative. Ma a livello regionale e locale, ci sono segnali di apertura. Supportare e non punire è una strategia più efficace per tutelare la salute e i diritti delle persone.
Per quanto riguarda il nostro lavoro nei festival e negli eventi, ci sono molte misure che potrebbero migliorare le condizioni. Ad esempio, l‘aumento dei finanziamenti per la sanità in generale è fondamentale, dato che il sistema sanitario è in sofferenza da tempo. Il Piemonte è un esempio positivo: ha riconosciuto la riduzione del danno e il drug checking come Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma servirebbe un’adozione simile in altre regioni per migliorare i servizi a livello nazionale.
Guardando all’Europa, la situazione varia. In Portogallo, la riduzione del danno non è riconosciuta come servizio sanitario, mentre in Austria ci sono ottime collaborazioni locali, ma il resto del paese rimane scoperto. Anche in Spagna, pur con eccellenze in alcune aree, ci sono molte regioni senza copertura adeguata. Al nord Europa, grazie a maggiori risorse, ci sono servizi più efficienti, ma i problemi organizzativi e di rapporto con le autorità sono simili.
Cosa consiste la vostra presenza?
Offriamo tre aree di intervento: un banchetto informativo con materiali di riduzione del danno, un punto per l’analisi delle sostanze e un’area chill-out per decompressione e supporto sanitario. La configurazione varia in base alle esigenze del festival e alle risorse disponibili.
Come vedete il futuro della riduzione del danno?
Siamo ottimisti. C’è maggiore consapevolezza e interesse verso la riduzione del danno, sia da parte degli organizzatori che del pubblico. Questa consapevolezza si sta espandendo, con richieste crescenti per servizi come il drug checking, anche in aree remote. Il coinvolgimento dei media ci permette di diffondere ulteriormente le nostre pratiche, creando un effetto a catena positivo.
Il Presente è Nuovo Paradigma?
Negli ultimi due decenni, la riduzione del danno si è evoluta oltre il campo della dipendenze da sostanze. Oggi, il concetto viene applicato anche in ambiti come il gioco d’azzardo, l’abuso di alcool e la sessualità a rischio. Le politiche di riduzione del danno rappresentano un approccio pragmatico e supportivo alla gestione di comportamenti rischiosi.
I dati scientifici supportano fortemente l’efficacia di questi interventi: non solo riducono i decessi e la trasmissione di malattie, ma migliorano la qualità della vita delle persone coinvolte, offrendo loro accesso a trattamenti sanitari e sociali senza stigmatizzazioni.
L’Importanza della Riduzione del Danno
La riduzione del danno non è solo una questione di politica sanitaria, ma di diritti umani. Essa si basa sul principio che ogni individuo ha diritto di conoscenza e a un’assistenza sanitaria dignitosa, un principio costituzionale, sancito dall’ART 32 della Costituzione, indipendentemente dalle proprie scelte di vita. Piuttosto che giudicare o punire, la RDD cerca di proteggere le persone dai rischi più gravi associati al loro comportamento.
A distanza di oltre mezzo secolo dalle prime sperimentazioni, la riduzione del danno ha dimostrato di essere uno degli strumenti più efficaci per affrontare le problematiche legate al consumo di sostanze e alle dipendenze. Eppure, per realizzare pienamente il suo potenziale, è necessario un cambiamento culturale e politico più profondo. È fondamentale che i governi, inclusa l’Italia, investano in politiche di prevenzione e riduzione del danno, offrendo alle persone più vulnerabili gli strumenti per vivere una vita più sana e sicura.
Il futuro della riduzione del danno è un banco di prova per le nostre società: sapremo costruire politiche che mettano davvero al centro la dignità e la salute delle persone?
Leggi anche : Outcast: 12 anni di “emarginazione” in una tracklist esclusiva per Parkett
L'articolo La riduzione del danno: dai rave ai club sembra essere il primo su Parkett.