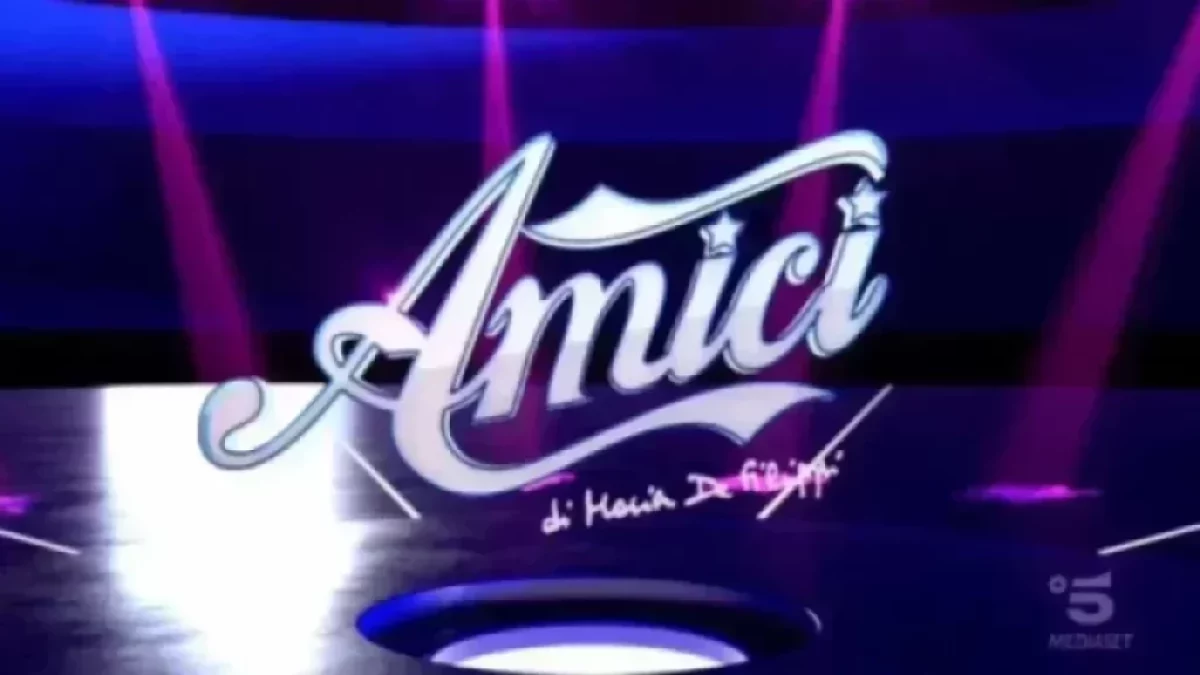Guida ai misteri di "Roma Celeste"
AGI - Il nome della città è Roma, “celeste” è l’attributo per la spiritualità dell’arte che vi si risiede e “misteri” - in chiave teologica, come per esempio spiega il vocabolario Treccani – sta a indicare le verità che si comprendono quando sono rivelate. Ma come si fa ad arrivare alla rivelazione? Sembra più roba da mistici che da semplici mortali. Forse porre alcune domande può aiutare: cosa volevano dire i maestri che hanno realizzato tanta bellezza? come hanno fatto a raggiungere vette espressive così alte? Perché le loro opere si trovano proprio a Roma? La guida non è la rassegna completa della produzione dei celeberrimi geni di scalpello e pennello, perché dovrebbe essere fitta di note e scritta con una prosa più adeguata. Il testo intende proporre alcuni itinerari religiosi ai quali il cristianesimo dà un particolare valore simbolico e che il Giubileo 2025 - aperto il 24 dicembre scorso e che si concluderà nello stesso mese di quest’anno - sembra l’occasione ideale per tentare di fare luce sul significato della Capitale e della sua arte. La prima domanda: che senso ha tanta meraviglia? I celebri virtuosi volevano toccare il Cielo con dito, rappresentare la dimensione “celeste” e far scivolare l’ammiratore nella preghiera. Probabilmente per vivere quell’aspirazione i capolavori non vanno visti con gli occhi di oggi ma si dovrebbe provare a guardarli con quelli di ieri. Secondo quesito: gli autori come sono arrivati ad avere certe intuizioni? Nella loro epoca era il trascendente a dare senso alla vita, alla morte e anche all’aldilà, ritenuto luogo di salvezza o dannazione. Per fede o per paura nessuno dubitava del dopo. Religione, sante, santi e pazzi di Dio erano considerati messaggeri “celesti”, e anche l’arte si credeva avesse le ali. Erano tempi in cui l’invisibile spiegava il visibile. In seguito ha cominciato a farsi strada il dubbio: l’invisibile esiste, non esiste? E oggi l’affermazione che corre di più è che non è mai esistito, o è facile sentirla dire. Infine, l’ultimo quesito: perché questo incanto si trova proprio a Roma: sculture, quadri, chiese o monumenti che siano? Il bello è sempre stato palcoscenico del sublime: “Il fine dell’arte è di rivelare l’immagine della natura divina”, scrive nel Simbolismo del tempio cristiano Jean Hani (1917-2012), filosofo francese e professore di civiltà e letteratura greca all'Università di Amiens, in Francia. E la Caput mundi è una delle residenze mondiali dove il sacro splende, impassibile allo scorrere del tempo e perciò città eterna come diceva il poeta romano Albio Tibullio (I secolo a.C.). Ciascuna tappa di questa guida è legata all’altra e unite segnano un percorso che, sempre muovendosi sul binario cristiano, rivela i misteri di Roma Celeste. Di questo fantastico viaggio si conoscono la corsa di andata e le soste che si dovranno fare. Ma non si sa bene cosa succederà a giro concluso. C’è una frase del critico letterario George Steiner che rende bene la situazione: “Noi leggiamo un libro, ma più profondamente è un libro a leggere noi”. Da osservatori si potrebbe finire osservati.

AGI - Il nome della città è Roma, “celeste” è l’attributo per la spiritualità dell’arte che vi si risiede e “misteri” - in chiave teologica, come per esempio spiega il vocabolario Treccani – sta a indicare le verità che si comprendono quando sono rivelate.
Ma come si fa ad arrivare alla rivelazione? Sembra più roba da mistici che da semplici mortali. Forse porre alcune domande può aiutare: cosa volevano dire i maestri che hanno realizzato tanta bellezza? come hanno fatto a raggiungere vette espressive così alte? Perché le loro opere si trovano proprio a Roma? La guida non è la rassegna completa della produzione dei celeberrimi geni di scalpello e pennello, perché dovrebbe essere fitta di note e scritta con una prosa più adeguata. Il testo intende proporre alcuni itinerari religiosi ai quali il cristianesimo dà un particolare valore simbolico e che il Giubileo 2025 - aperto il 24 dicembre scorso e che si concluderà nello stesso mese di quest’anno - sembra l’occasione ideale per tentare di fare luce sul significato della Capitale e della sua arte.
La prima domanda: che senso ha tanta meraviglia? I celebri virtuosi volevano toccare il Cielo con dito, rappresentare la dimensione “celeste” e far scivolare l’ammiratore nella preghiera. Probabilmente per vivere quell’aspirazione i capolavori non vanno visti con gli occhi di oggi ma si dovrebbe provare a guardarli con quelli di ieri. Secondo quesito: gli autori come sono arrivati ad avere certe intuizioni? Nella loro epoca era il trascendente a dare senso alla vita, alla morte e anche all’aldilà, ritenuto luogo di salvezza o dannazione. Per fede o per paura nessuno dubitava del dopo. Religione, sante, santi e pazzi di Dio erano considerati messaggeri “celesti”, e anche l’arte si credeva avesse le ali. Erano tempi in cui l’invisibile spiegava il visibile. In seguito ha cominciato a farsi strada il dubbio: l’invisibile esiste, non esiste? E oggi l’affermazione che corre di più è che non è mai esistito, o è facile sentirla dire.
Infine, l’ultimo quesito: perché questo incanto si trova proprio a Roma: sculture, quadri, chiese o monumenti che siano? Il bello è sempre stato palcoscenico del sublime: “Il fine dell’arte è di rivelare l’immagine della natura divina”, scrive nel Simbolismo del tempio cristiano Jean Hani (1917-2012), filosofo francese e professore di civiltà e letteratura greca all'Università di Amiens, in Francia. E la Caput mundi è una delle residenze mondiali dove il sacro splende, impassibile allo scorrere del tempo e perciò città eterna come diceva il poeta romano Albio Tibullio (I secolo a.C.).
Ciascuna tappa di questa guida è legata all’altra e unite segnano un percorso che, sempre muovendosi sul binario cristiano, rivela i misteri di Roma Celeste. Di questo fantastico viaggio si conoscono la corsa di andata e le soste che si dovranno fare. Ma non si sa bene cosa succederà a giro concluso. C’è una frase del critico letterario George Steiner che rende bene la situazione: “Noi leggiamo un libro, ma più profondamente è un libro a leggere noi”. Da osservatori si potrebbe finire osservati.



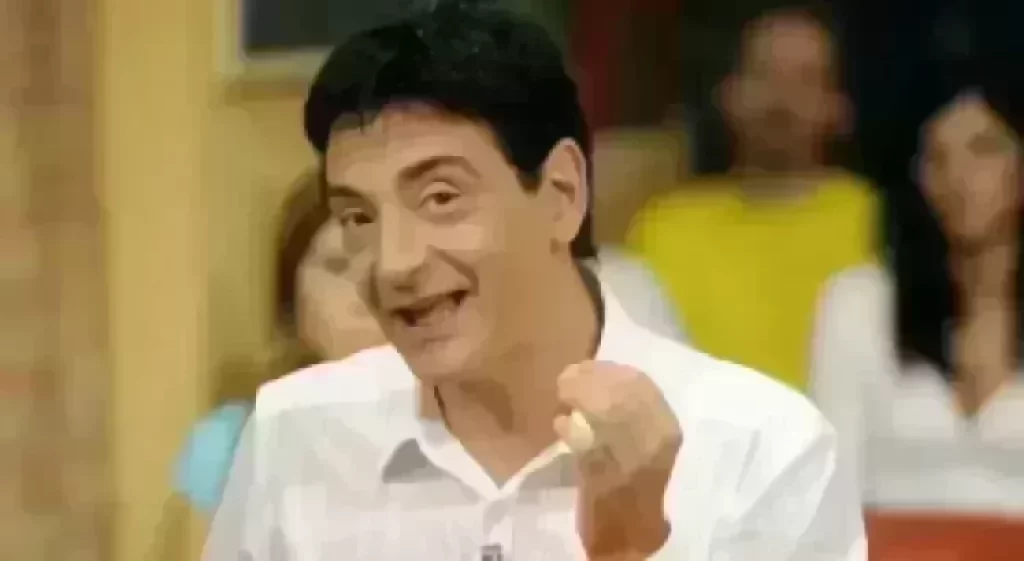





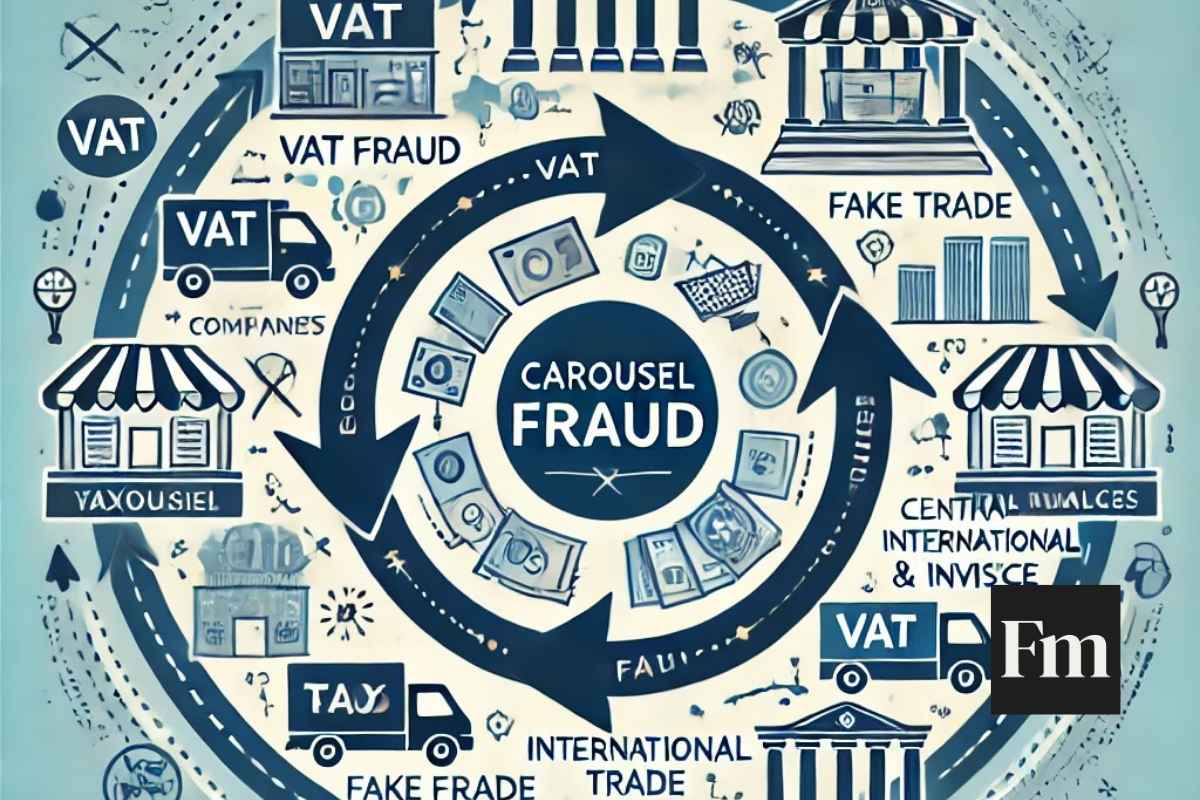


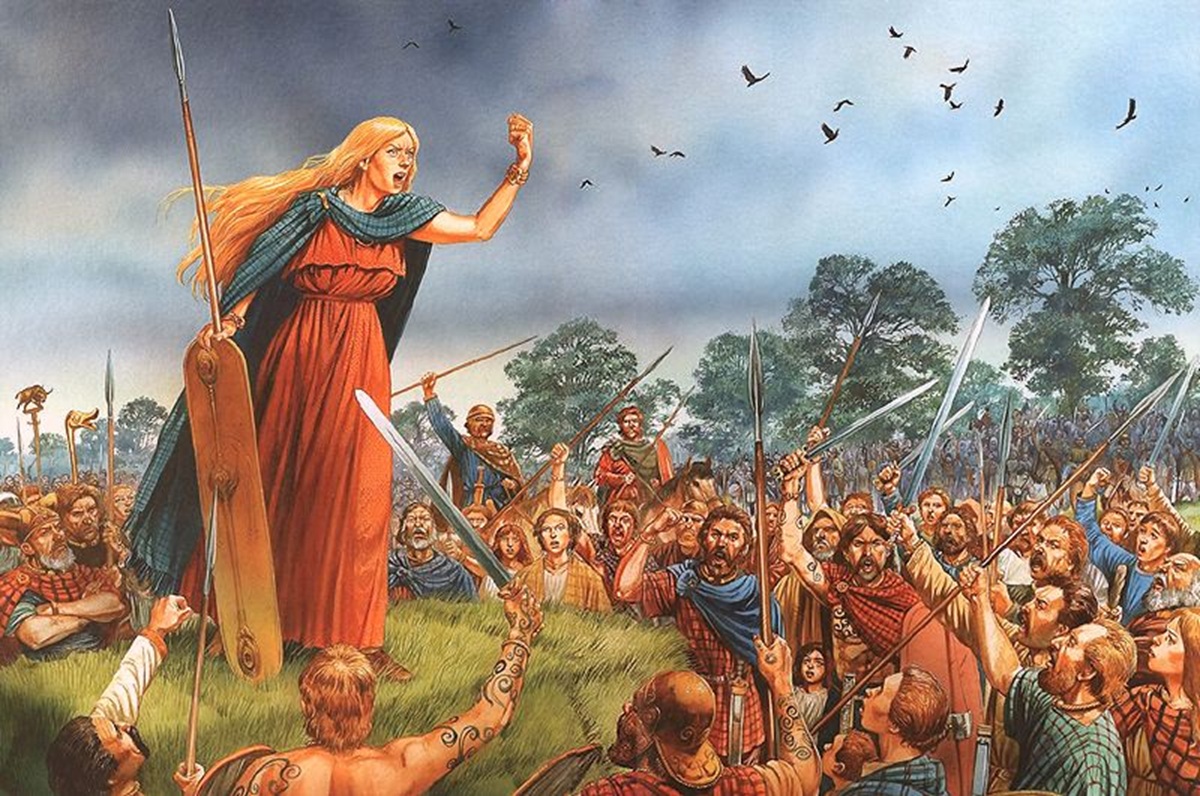













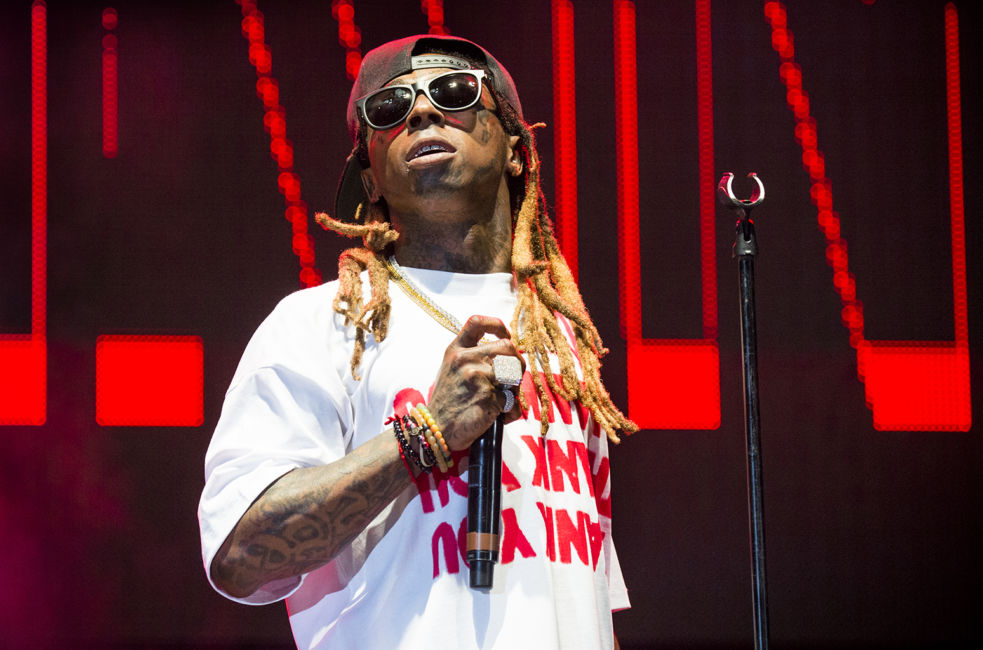




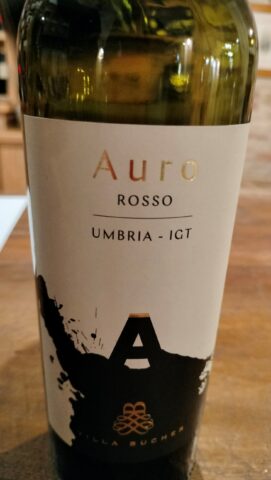


















![F1, Il primo giorno di Carlos Sainz in Williams [ VIDEO ]](https://www.circusf1.com/f14/wp-content/uploads/2025/02/sainz_williams_f1.png)