Al bando il taylorismo passiamo all’«olocrazia»
Coinvolgere le persone dando "potere di pensare" a tutti risolve quello che Stefano Zamagni definisce «il trilemma ecologico», armonizzando le tre componenti della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica L'articolo Al bando il taylorismo passiamo all’«olocrazia» proviene da Economy Magazine.

La sostenibilità sociale fa crescere le imprese attraverso il coinvolgimento di tutti i lavoratori e la valorizzazione dei loro talenti, ovvero un modello che è stato rilanciato ad Harvard ma esisteva già nella Toscana del Quattrocento. Ma perché la transizione abbia successo si deve risolvere il trilemma ecologico, riuscendo ad armonizzare le tre componenti della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. «Il modo c’è, ma bisogna prima essere convinti dell’urgenza, e mettersi a studiare seriamente invece di fare proclami» dice in questa intervista a Economy l’economista Stefano Zamagni, punto di riferimento sulle tematiche sociali e del terzo settore.
Le aziende hanno compreso che la sostenibilità sociale fa crescere?
Qual è l’implicazione più importante della rivoluzione digitale? È che il fattore di vantaggio competitivo oggi è la creatività prima, e l’innovatività poi; non più la disponibilità di certe materie prime che una volta permetteva alle imprese di dominare il mercato. Oggi è chi è più rapidamente innovativo a dominarlo. Allora la domanda è: come si fa ad aumentare il tasso di innovatività? Trattando le persone che operano dentro l’impresa a tutti i livelli, da quelli del top management agli intermedi a quelli bassi, come se fossero persone umane. Vuol dire una cosa specifica: buttare al macero il modello taylorista, che è quello che ci sta rovinando, soprattutto a noi italiani. È nato nel 1911 e ha avuto successo fino agli anni ’60, da allora è cominciato il disastro. L’idea che Taylor ha messo nero su bianco è semplice: i dipendenti dell’impresa non devono pensare, sono pagati non per pensare ma solo per obbedire. Taylor ha scritto testualmente che vanno trattati come se fossero dei bovini. Il bue non pensa ed è l’animale più docile, gli dai un colpo e non succede niente.
Questa idea è ancora adottata?
È ancora dominante. Come si fa a innovare se l’organizzazione d’impresa decide che all’innovazione pensa solo un gruppetto di persone che sta in quell’ufficio e occupa quel livello? È una fesseria, le idee possono arrivare anche dall’ultimo arrivato, dal più giovane, dalla persona da cui neanche te lo aspetteresti, che ti può proporre un’idea che opportunamente elaborata ti fa avere successo. Chi l’aveva capito in anticipo sui tempi? Adriano Olivetti. Non per niente la sua è l’impresa italiana ancora oggi la più nota all’estero. È morto nel 1960 ma tutti lo conoscono, mica si ricordano di Valletta della Fiat… Olivetti faceva pensare tutti, stimolava anche l’ultimo operaio semianalfabeta perché producesse suggerimenti. Ecco qual è il punto oggi: l’organizzazione d’impresa deve valorizzare i talenti di tutti, perché li abbiamo tutti, c’è chi ne ha un po’ di più chi un po’ meno, ma anche chi ne ha di meno in un determinato contesto può venir fuori con un’idea vincente, alla quale chi ne ha di più non aveva pensato.
Come andare in questa direzione?
Bisogna buttare al macero il modello taylorista e adottare l’altro modello anti taylorista che si chiama olocratico, ed è stato introdotto in America nel 2007. L’hanno inventato a Harvard, lo adottano le imprese di maggior successo americane, e noi siamo ancora qui che cerchiamo di mettere cerotti al modello taylorista. Olocrazia è una parola greca, gli americani non hanno molta cultura ma sono furbi: olocrazia vuol dire il potere a tutti – olos tutti, cratos potere – in questo caso il potere è quello di pensare, suggerire, a tutti, anche quelli che puliscono per terra.
In Italia non si fa?
Il tipico atteggiamento italiano è: per valorizzarlo gli diamo un aumento di stipendio. Non che non serva, il lavoratore è più contento ma non è quello il punto, si deve valorizzare il suo potenziale di talento, il che si ottiene non dando più soldi, ma facendo sentire la persona importante: allora è contenta di esternalizzare quella che si chiama la conoscenza tacita. Alcune decine di imprese italiane che conosco hanno adottato questo modello e stanno avendo un successo straordinario. Quando un’azienda fallisce invece si scopre che in una forma o nell’altra ha continuato il modello taylorista. Eppure il coinvolgimento e la valorizzazione dei lavoratori è nel nostro Dna: ho citato Olivetti, ma l’impresa moderna nasce in Toscana nel 1400. Leonardo da Vinci era un imprenditore, bisogna leggere quello che scriveva sulla bottega artigiana. È un modello che oggi è studiato all’estero, ma non in Italia. Siccome era un genio, ai suoi collaboratori alla bottega faceva, come dire, delle lezioni. Questi erano contentissimi di imparare da un tale maestro, e quindi rendevano molto, ma molto di più. Queste cose noi le abbiamo nel sangue, a partire dal 1400!
Ma la sostenibilità sociale è ancora percepita come un costo, se non un lusso?
Il problema è il cosiddetto trilemma ecologico: la sostenibilità ha tre dimensioni, ambientale, sociale ed economica. A tutt’oggi non esiste una teoria o un modello capace di farle marciare assieme, al massimo ne tiene assieme due: tutti i problemi nascono da questo. C’è chi dice: per noi sono importanti gli aspetti ambientale ed economico, alla sostenibilità sociale ci penserà qualcun altro, oppure dobbiamo rassegnarci. Sostenibilità sociale vuol dire che i costi della transizione verde ricadono su certe categorie di soggetti, non solo operai ma anche imprenditori: è chiaro che questi che risultano penalizzati si oppongono. L’esempio più vivido ce l’abbiamo avuto qualche mese fa, quando l’Ue aveva stretto le norme sulla sostenibilità ambientale, e i coltivatori diretti hanno preso i trattori e marciato su Bruxelles, finché l’Ue non ha fatto marcia indietro. Altri invece dicono: vogliamo la sostenibilità ambientale e sociale a scapito di quella economica. In questo caso protesta un altro tipo di imprese: quelle delle armi, i petrolieri, chi produce automobili non elettriche. Se si dice invece puntiamo sulla sostenibilità sociale ed economica e trascuriamo quella ambientale, scendono in piazza gli ambientalisti.
Qual è la soluzione?
Bisogna trovare il modello che armonizzi i tre tipi di sostenibilità, in modo che nessuna coalizione in chiave socio politico nasca per impedire la transizione. Il modo c’è, ma bisogna prima essere convinti dell’urgenza, e mettersi a studiare seriamente invece di fare proclami. Purtroppo in Italia, in Europa, nel mondo non si riesce far passare questa idea. Quindi la Cop di Baku si è conclusa con un niente di fatto, in Europa si torna indietro rispetto al green deal, non parliamo di Trump che riapre le centrali a carbone e petrolio, fregandosene della sostenibilità ambientale. Ecco allora l’approccio che oggi sta guadagnando terreno, siamo ancora in minoranza numerica, però le migliori teste a livello mondiale sono su questa linea: bisogna risolvere il trilemma della sostenibilità.
Chi è stato il primo ad avanzare questo approccio?
Il premio Nobel John Hicks, il più grande economista del Novecento insieme a Keynes. Già nel 1973 nel volume Capital and Time: A Neo-Austrian Theory, metteva in evidenza che quando si passa da un equilibrio a un altro c’è un periodo di passaggio, che definiva sentiero di traversa, durante il quale alcuni segmenti della società guadagnano e altri ci rimettono; questi ultimi si coalizzano in sede politica per bloccare il processo. L’ha scritto più di 50 anni fa, ed è proprio quel che sta succedendo oggi. Ma prova a chiedere a un professore di economia se ha letto Capital and time… Bisogna dirle queste cose, e non illudersi che si possa andare avanti tappando i buchi: adesso accontento quella categoria, l’anno prossimo l’altra. Questo è l’errore più grave che si possa commettere.
L'articolo Al bando il taylorismo passiamo all’«olocrazia» proviene da Economy Magazine.













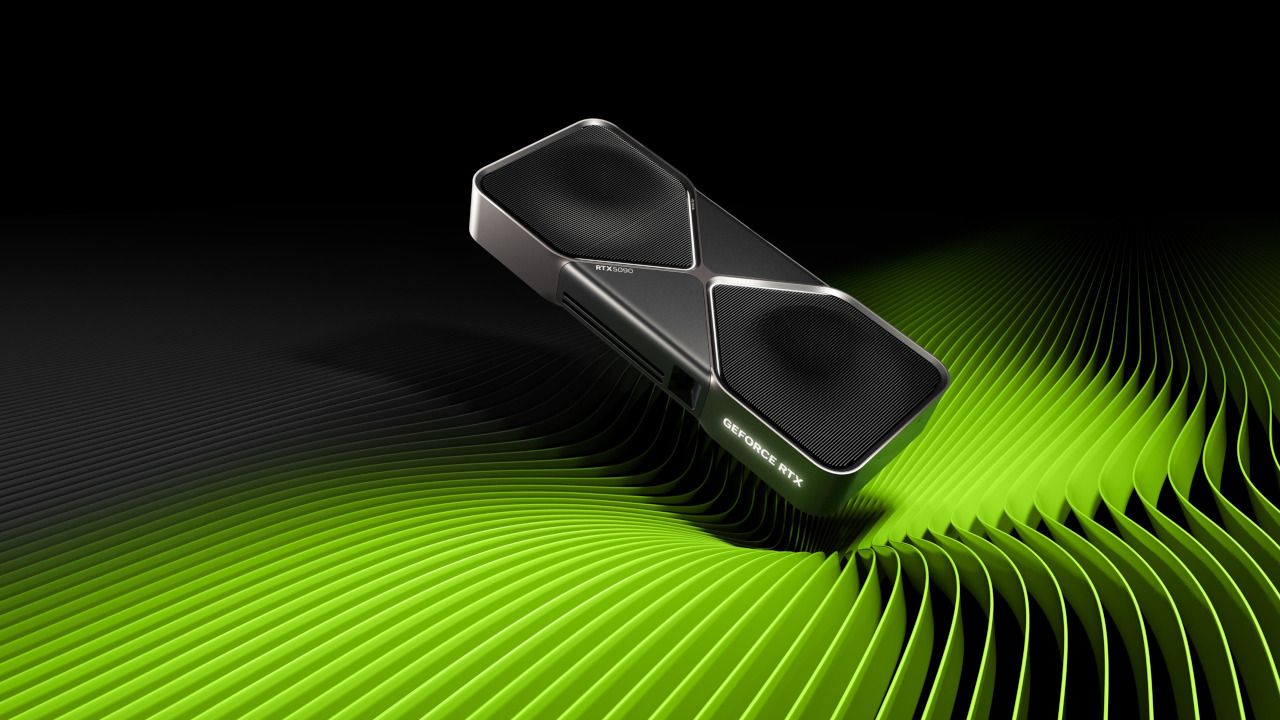

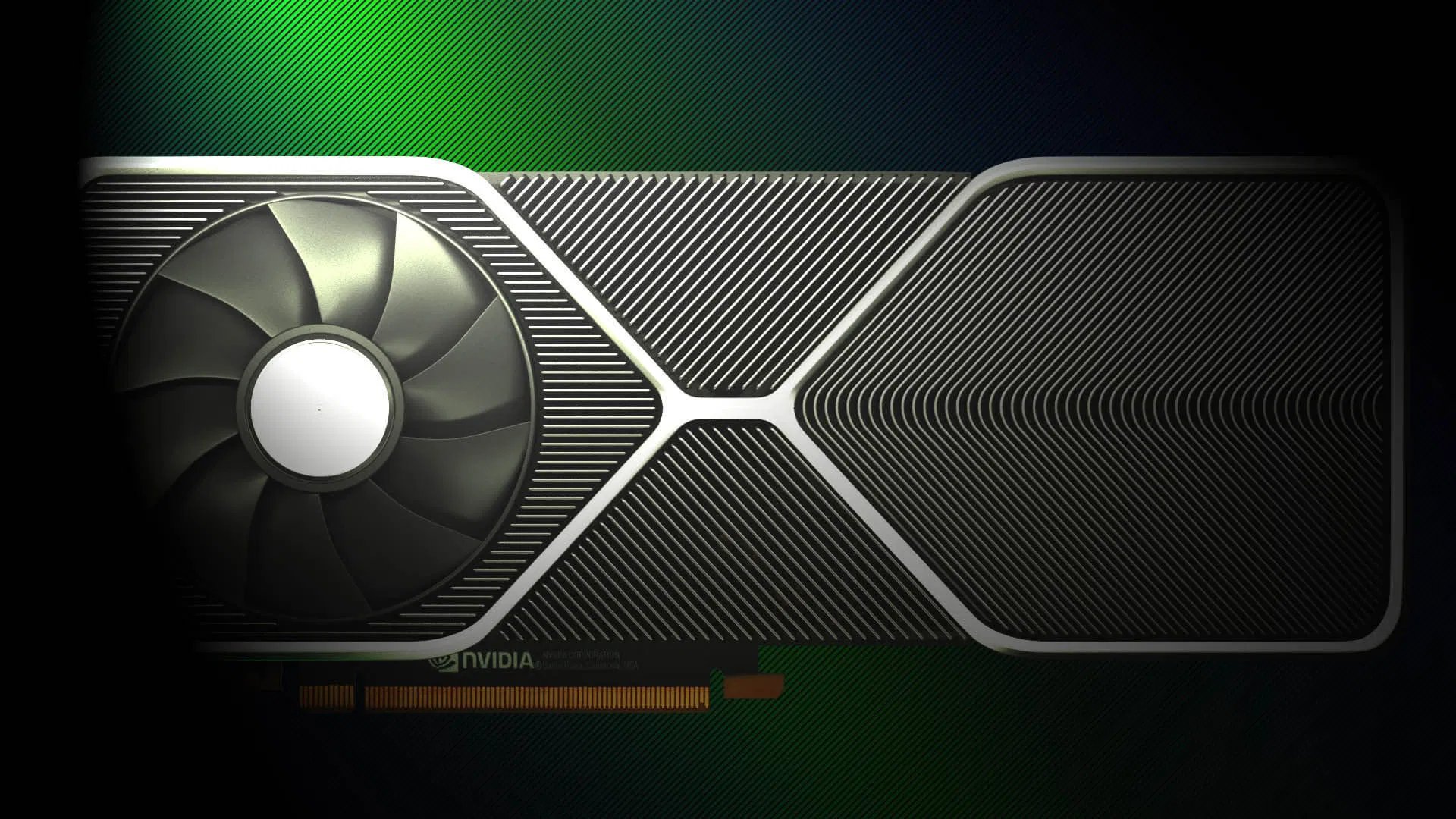

























![La guida allo sport in tv oggi [domenica 2 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)




