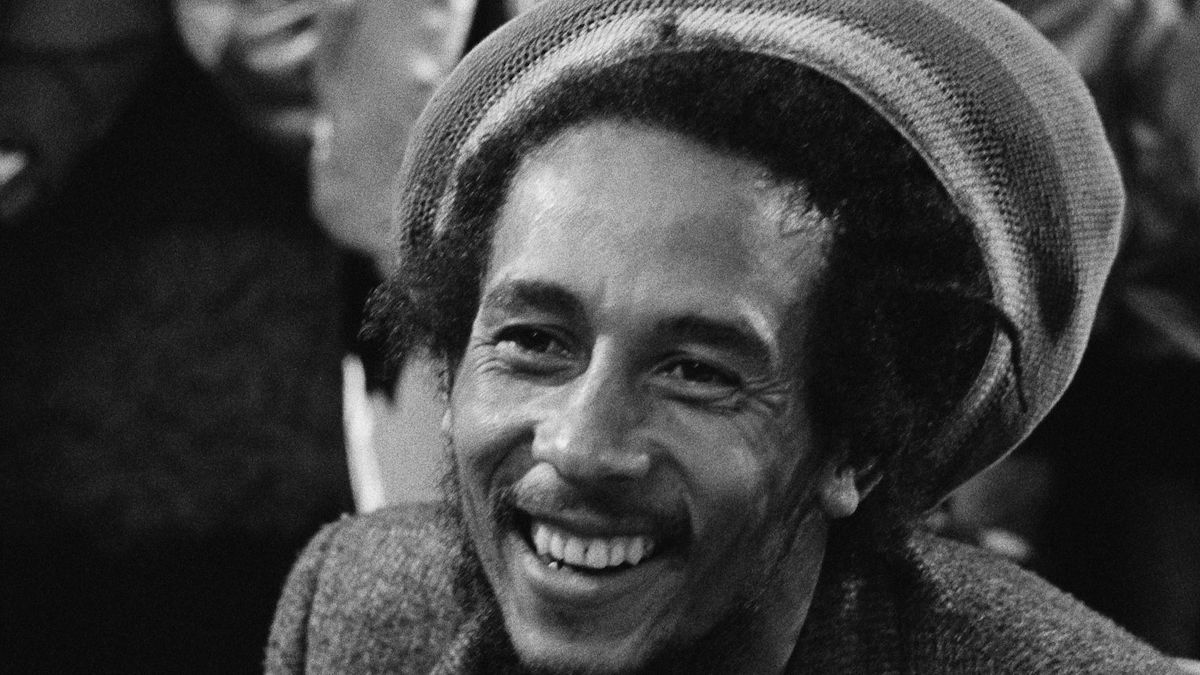Per l’Italia digitale serve un “Piano Olivetti”
Senza una vera conoscenza di concetti, teorie e metodi dell’informatica, l’Italia rischia di pagare un prezzo enorme in termini di possibilità di scegliere la sua direzione di sviluppo nella società digitale. L'analisi del professore Enrico Nardelli dell’università di Roma Tor Vergata, direttore del Laboratorio Nazionale “Informatica e Scuola” del CINI e già presidente di Informatics Europe

Senza una vera conoscenza di concetti, teorie e metodi dell’informatica, l’Italia rischia di pagare un prezzo enorme in termini di possibilità di scegliere la sua direzione di sviluppo nella società digitale. L’analisi del professore Enrico Nardelli dell’università di Roma Tor Vergata, direttore del Laboratorio Nazionale “Informatica e Scuola” del CINI e già presidente di Informatics Europe
Finalmente sul Corriere della Sera, sezione Economia, ci si accorge dell’importanza per l’Italia di possedere il controllo sulle infrastrutture digitali. Ferruccio de Bortoli, in un‘analisi sullo stato dell’innovazione digitale in Italia, invita a “a credere di più in sé stessi, ad avere fiducia nel futuro, a non arrendersi anticipatamente quando la partita … sembra ormai irrimediabilmente perduta“. Ovviamente si parla di Intelligenza Artificiale, perché la sua fragorosa irruzione nella vita di tutti i giorni ha fatto capire a tutti qual è l’importanza dell’informatica nella società odierna .
Meglio tardi che mai, mi è venuto da pensare, visto che ne parlo pubblicamente da molto tempo. Non certo noto come Stefano Quintarelli che, giustissimamente viene citato da de Bortoli a proposito di tante innovazioni che in Italia non trovano spazio, avevo già scritto più di quattro anni fa dell’importanza che il nostro sistema educativo si dotasse di un’infrastruttura digitale pubblica, e dell’interesse nazionale a curare lo spazio digitale così come accade per lo spazio fisico. Esigenze che de Bortoli scopre adesso attraverso le parole di Quintarelli, anche lui da molto tempo inascoltato fautore dell’importanza di questi temi. Stefano è stato anche deputato e, nonostante le sue indubbie capacità, non è riuscito a farsi ascoltare dalla politica su questi temi: nel frattempo, il mondo è andato avanti.
Prima di lui altri intellettuali di valore hanno cercato di convincere i decisori politici dell’importanza dell’informatica per lo sviluppo del Paese. Due fra tutti, Giovan Battista Gerace e Mario Bolognani. Tutto invano. A cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 con l’Olivetti eravamo all’avanguardia nel mondo dell’informatica. Il primo personal computer (P101) era stato realizzato da loro e la NASA ne usò 45 per preparare la missione Apollo 11 che sbarcò sulla luna nel 1969. Ma poi, politici, “ministri occasionali”, economisti e “capitani coraggiosi” non riconobbero l’importanza strategica di sostenere l’azienda, che aveva delle difficoltà finanziarie, per continuare a far crescere l’Italia in quella direzione e si limitarono a ripetere in continuazione “il treno è perso”. Ma a partire dagli anni ‘80 ne sono arrivati di nuovi, su cui altri sono stati in grado di salire a bordo: Internet, i social media, e adesso l’intelligenza artificiale generativa. Noi ci siamo riempiti la bocca di trasformazione digitale, pensando che si potesse realizzare acquistando tecnologia senza investire nell’istruzione scolastica e universitaria. Nell’ultimo decennio è riecheggiato in modo ossessivo il mito della “scuola digitale”, salvo poi dover constatare che l’UNESCO ha attestato la tragedia dell’istruzione digitale.
L’innovazione nel digitale non si inventa, serve la formazione e bisogna cominciare almeno vent’anni prima. L’exploit cinese con DeepSeek non è arrivato all’improvviso, è il risultato di un periodo di investimenti in istruzione sia di base che superiore e in ricerca che la Cina ha iniziato da moltissimo tempo. Serve studiare informatica, nella scuola, nell’università. Serve finanziare la ricerca in informatica e nelle sue tecnologie, anche la ricerca di base, senza illudersi che sia solo l’eccellenza quella che conta. Per avere l’eccellenza del singolo bisogna comunque investire nella preparazione media della massa. Per avere l’eccellenza di un Paese bisogna investire nella preparazione media dei suoi cittadini.
È ormai da dieci anni che io personalmente spingo sull’importanza far studiare informatica nella scuola, sia perché tutti i cittadini devono conoscere come funziona il mondo digitale intorno a noi, sia perché una conoscenza di base di questa materia è necessaria per far sì che più ragazzi, e soprattutto più ragazze, la scelgano come materia dei loro studi tecnici o universitari. E se non abbiamo più studenti nelle università in questi settori, i ricercatori per sviluppare i sistemi informatici di avanguardia non potremo mai trovarli. Per chi volesse approfondire ecco i miei interventi divulgativi a stampa e in video.
Negli ultimi venti o trent’anni ho invece sentito generalmente parlare solo di competenze digitali declinate in senso operativo (ricordate la famigerata patente del computer?), nell’incomprensione generale da parte di chi dovrebbe avere gli strumenti culturali per capire come si sta evolvendo la società e guidare il Paese lungo questo percorso. Stiamo sprecando centinaia di milioni di euro del PNRR nelle scuole comprando tecnologia realizzata altrove invece di formare seriamente i docenti per insegnare informatica nella scuola, come ormai anche il Consiglio dell’Unione Europea raccomanda.
Senza una vera conoscenza di concetti, teorie e metodi dell’informatica, l’Italia rischia di pagare un prezzo enorme in termini di possibilità di scegliere la sua direzione di sviluppo nella società digitale perché sarà sempre più dipendente da sistemi e conoscenze che non le appartengono e soggetta alla sorveglianza di chi le possiede.
Sarebbe ora di risvegliarsi sul serio. Enrico Mattei e Adriano Olivetti, due italiani di genio che stavano guidando il Paese a essere leader mondiali, non ci sono più, ma la loro lezione è ancora valida. Dopo il “Piano Mattei” ci serve un “Piano Olivetti”.
(I lettori interessati potranno dialogare con l’autore, a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, su questo blog interdisciplinare.)