Un dialogo “vegetale” tra musica e botanica
Il 22 febbraio alle 18 all'Auditorium di Milano, il botanico Stefano Mancuso e il compositore Nicola Campogrande dialogheranno sul tema "Il pianeta delle piante" accompagnati dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Nicolò Jacopo Suppa, con Claudio Bonfiglio al pianoforte.
Quando un compositore e un botanico si incontrano, cosa succede? Difficile immaginarlo, ma possiamo scoprirlo grazie all'appuntamento intitolato "Il pianeta della piante" di sabato 22 febbraio alle ore 18 all'Auditorium di Milano, quando Stefano Mancuso, botanico e divulgatore, si pone in dialogo con Nicola Campogrande, compositore in residenza dell'Orchestra Sinfonica di Milano, accompagnati dalle note eseguite dalla compagine di Largo Mahler diretta da Nicolò Jacopo Suppa e da Claudio Bonfiglio al pianoforte.
Un incontro che ci permette di interrogarci sul nostro rapporto con la natura, per immaginare un futuro in cui la presenza antropica minacci sempre meno la diversità della natura. Le piante rappresentano la quasi totalità della vita sul nostro pianeta, eppure spesso ne sottovalutiamo l'importanza e le capacità straordinarie, come l'intelligenza e la comunicazione con l'ambiente. Le città sono il principale motore dell'aggressione ambientale da parte dell'uomo. Per questo, Nicola Campogrande propone Urban Gardens, per pianoforte e orchestra, composizione ispirata agli orti urbani, una delle novità più affascinanti tra quelle che stanno trasformando le nostre città. "Muovendo da quell'idea, ho immaginato il pianoforte come memoria cittadina, tenendo bene in mente le diverse declinazioni alle quali si presta oggi lo strumento (musica classica, jazz, pop) – afferma Campogrande - e, intorno, ho pensato di far vivere l'orchestra come una presenza vegetale, organica, in continua trasformazione.".
Un perfetto corrispettivo sonoro dell'idea alla base dell'argomentazione di Stefano Mancuso: "Attualmente intorno al 70% del consumo globale di energia e oltre il 75% del consumo mondiale di risorse naturali sono a carico delle città, le quali producono il 75% delle emissioni di carbonio e il 70% dei rifiuti. Abbiamo urgente necessità di cambiare la nostra idea della città. Dobbiamo creare delle Fitopolis, delle città viventi; un luogo partecipe dell'ambiente naturale che, consapevolmente e attraverso gli alberi contribuisce a trasformare i nostri centri urbani in una nicchia ecologica duratura."
Ecco che la musica e le scienze naturali si interrogano sul delicato rapporto tra uomo e ambiente naturale, un rapporto impari, che vede da una parte la transitorietà di tutto ciò che è umano, e dall'altra la maestosa e irresistibile energia di tutto ciò che è naturale. Una visione che infonde l'intera produzione filosofica e artistica alla base del Romanticismo, connotato da una vera e propria riscoperta della grandiosità della natura, di fronte alla quale, a volte, l'artista si sente impotente. Dal Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, icona assoluta della pittura tedesca dell'Ottocento, fino alla Sinfonia n.6 di Beethoven, la "Pastorale", in programma nell'ambito della lezione-concerto di sabato 22 febbraio, pagina sinfonica con cui il compositore sembra raccontare in musica una passeggiata nella natura, e in cui sembra voler dipingere in musica ciò che incontra, ciò che accade durante quella esperienza. Tuttavia, sarà Beethoven stesso a sottolineare di aver voluto dare vita "più all'espressione di sensazioni che alla pittura", quasi prendendo le distanze da una certa tradizione di musica a programma che, nell'immaginario collettivo, poteva risultare di un livello inferiore rispetto alla descrizione in musica di sentimenti e delle emozioni umane. Niente di nuovo, se pensiamo che, tradizionalmente, la pittura del paesaggio è sempre stato considerata come qualcosa di inferiore rispetto alla rappresentazione dei corpi e delle passioni umane.. Ma è un'asimmetria che afferma le sue radici a livello (anche) neurologico, quella che separa l'uomo dalla natura che lo circonda. Si parla del curiosissimo fenomeno della Plant blindness, come racconta Stefano Mancuso: "Si tratta di una disfunzione cognitiva per cui l'essere umano non vede le piante, ai suoi occhi diventano praticamente invisibili. E non si tratta di una disfunzione localizzabile culturalmente, ascrivibile, ad esempio, solo all'uomo occidentale. Si tratta di un fenomeno che accomuna tutti gli esseri umani, e la cui spiegazione più plausibile risiede nel fatto che ci siamo evoluti e sviluppati in un mondo che era verde ed è sempre stato totalmente verde, e visto che il nostro cervello è una macchina in grado di computare mille bit di informazioni per secondo (a fronte dei cinque miliardi di bit che riceviamo), l'evoluzione ha fatto in modo da selezionare come rilevanti altre informazioni, quasi annullando la nostra percezione delle piante che ci circondano."
Un paradosso, per certi versi, dal momento che, in percentuale, le piante rappresentano l'87% delle forme di vita sulla Terra, la quasi totalità di tutto quanto è vivo sul nostro pianeta. L'uomo, a dispetto di quanto si possa immaginare, è una assoluta minoranza, rappresentando lo 0,3% delle forme di vita. Eppure, il suo impatto è determinante. Si pensi alle città, creazioni umane che, se ben ci pensiamo, vengono semplicemente "accolte" dalla natura che ci circonda. Ma, così come vengono accolte, possono essere anche risucchiate in essa. Una sensazione che viene rappresentata efficacemente proprio in Urban Gardens di Nicola Campogrande, dove il pianoforte rappresenta l'elemento antropico, portatore della memoria cittadina, letteralmente avvolto dall'orchestra, che rappresenta una presenza vegetale, organica, in continua trasformazione. "Si crea un movimento intorno al pianoforte, è la natura incontenibile che preme, che spinge con forza da sottoterra verso l'alto. E' un moto di crescita anarchica nel suo complesso, con cui tutto si colora di verde, di frutta e di verdura, si avverte la pressione di semi che si schiudono, di piante che crescono, di vegetali che vanno espandendosi.
È questa la Natura, la potenza del mondo vegetale, incredibilmente potente e finemente intelligente, che troppo spesso sottovalutiamo o dimentichiamo. Un mondo organizzato in modo molto diverso rispetto al mondo animale, come sottolinea Mancuso: "Noi siamo organismi centralizzati e specializzati mentre le piante sono decentralizzate e diffuse. L'uomo è costruito in maniera gerarchica, questa organizzazione gerarchica e piramidale è stata replicata anche nelle sue creazioni. Le piante hanno invece una struttura diffusa e decentralizzata, diffondendo tutte le funzioni vitali sull'intero corpo."
Ed è proprio in questo che, forse, potremmo e dovremmo imparare qualcosa dalle piante, in particolare ripensando la struttura e l'organizzazione alla base delle nostre città. Continua Mancuso: "Abbiamo costruito le città con regole molto semplici: nel centro stanno i centri di comando, e a livello decentralizzato abbiamo costruito quartieri specifici, specializzati e dedicati a precise funzioni. Sarebbe interessante pensare in modo diverso le nostre città, concependole come luoghi in cui tutto è diffuso e raggiungibile in poco tempo, una città organica non necessariamente organizzata secondo i principi di gerarchia ed efficienza, come siamo abituati a fare. Dobbiamo creare delle Fitopolis, delle città viventi; luoghi partecipi dell'ambiente naturale che, consapevolmente e attraverso gli alberi, contribuiscono a trasformare i nostri centri urbani in una nicchia ecologica duratura."
Una sensibilità che è di casa all'Auditorium di Milano, quella legata alle tematiche ambientali. Basti pensare all'adesione dell'Orchestra Sinfonica di Milano a Forestami, l'iniziativa che si propone di coinvolgere tutti, cittadine, cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030. L'istituzione di Largo Mahler ha tra i propri obiettivi la sostenibilità ambientale dei concerti e degli eventi prodotti ed essendo già impegnata nella transizione ecologica e nel contrasto al cambiamento climatico. L'appuntamento del 22 febbraio insieme a Stefano Mancuso e Nicola Campogrande incarna perfettamente l'atteggiamento della Fondazione nei confronti della sensibilizzazione verso il rispetto dell'ambiente che ci circonda.
. I lettori di Focus, media partner dell'Orchestra Sinfonica di Milano, possono usufruire dei biglietti scontati del 25% (14 €) scrivendo a marketing@sinfonicadimilano.org e inserendo nell'oggetto della mail "FOCUS"..







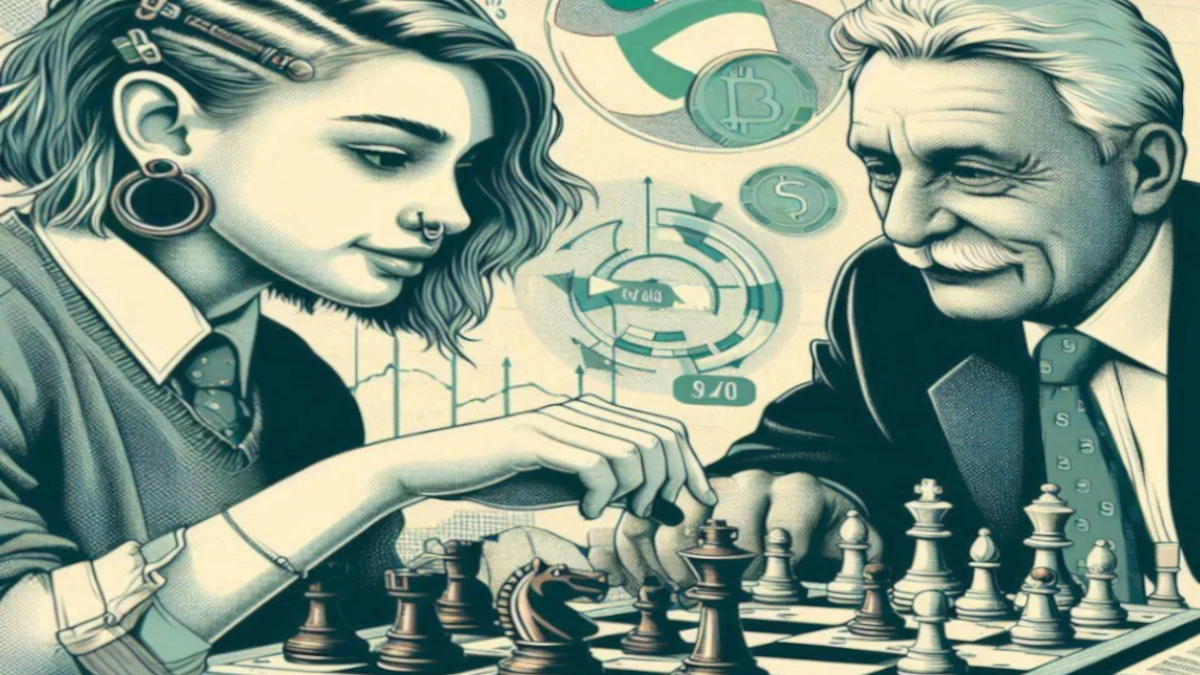
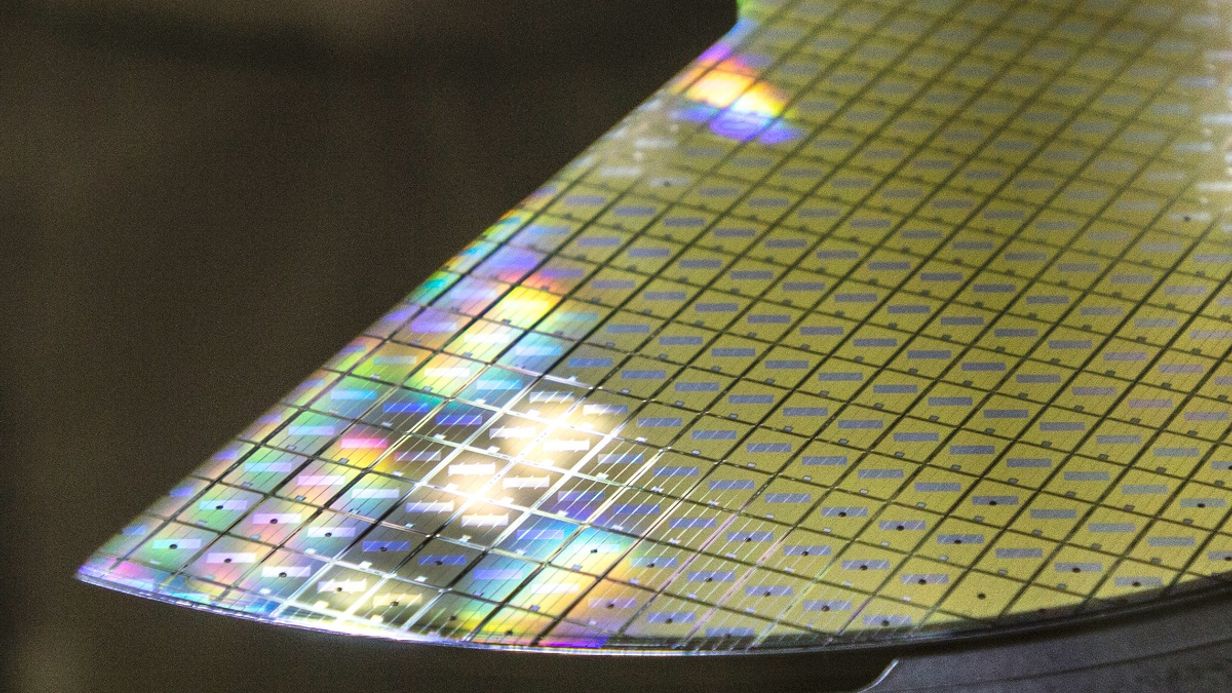

























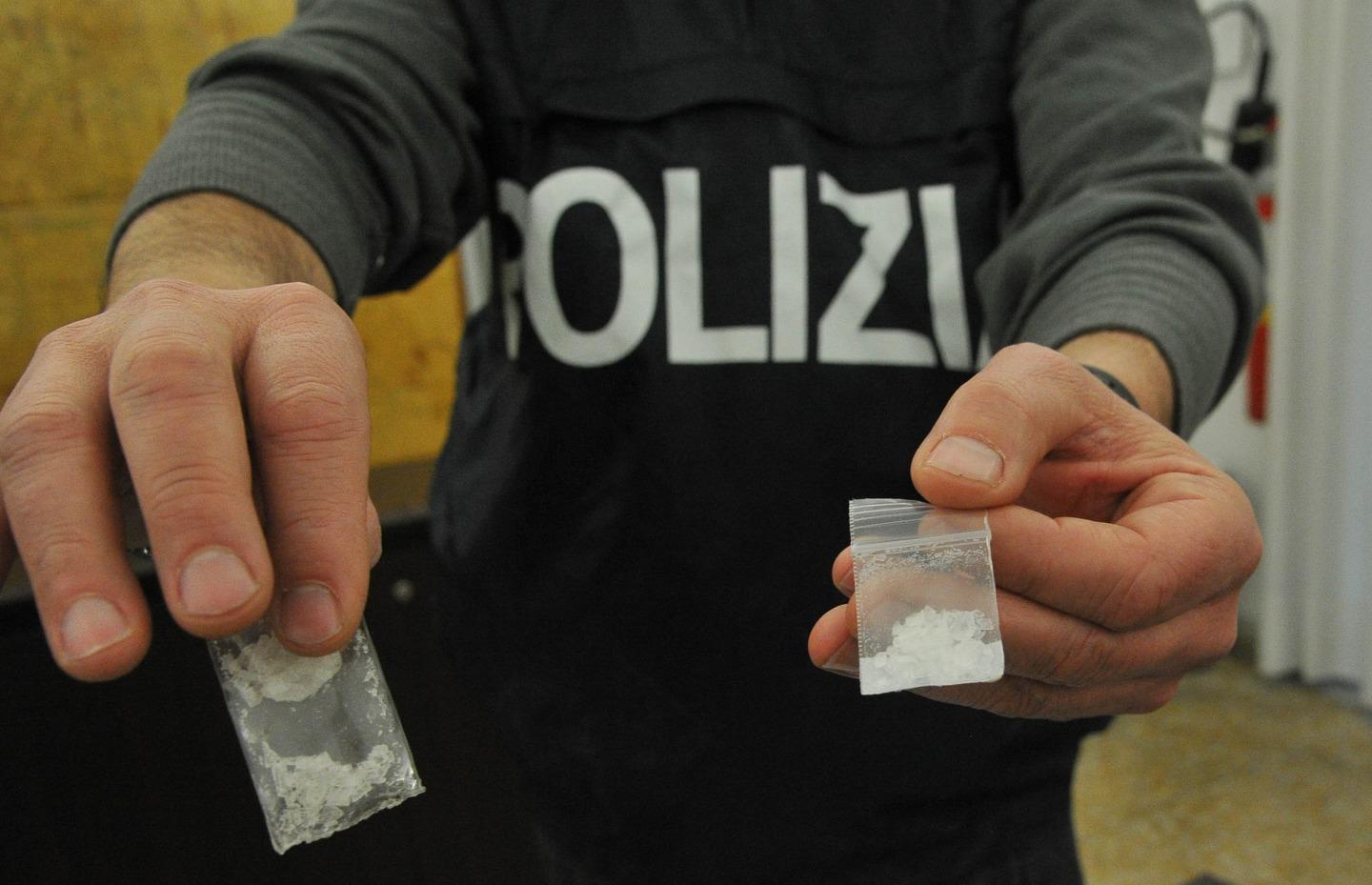







![La guida allo sport in tv oggi [lunedì 3 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)





