Il valore aggiunto nella filiera automotive e gli impatti della transizione elettrica
Il Valore Aggiunto è la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende. Quindi rappresenta il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’impresa, capitale e lavoro, hanno ‘aggiunto’ agli input acquistati dall’esterno […] The post Il valore aggiunto nella filiera automotive e gli impatti della transizione elettrica first appeared on QualEnergia.it.
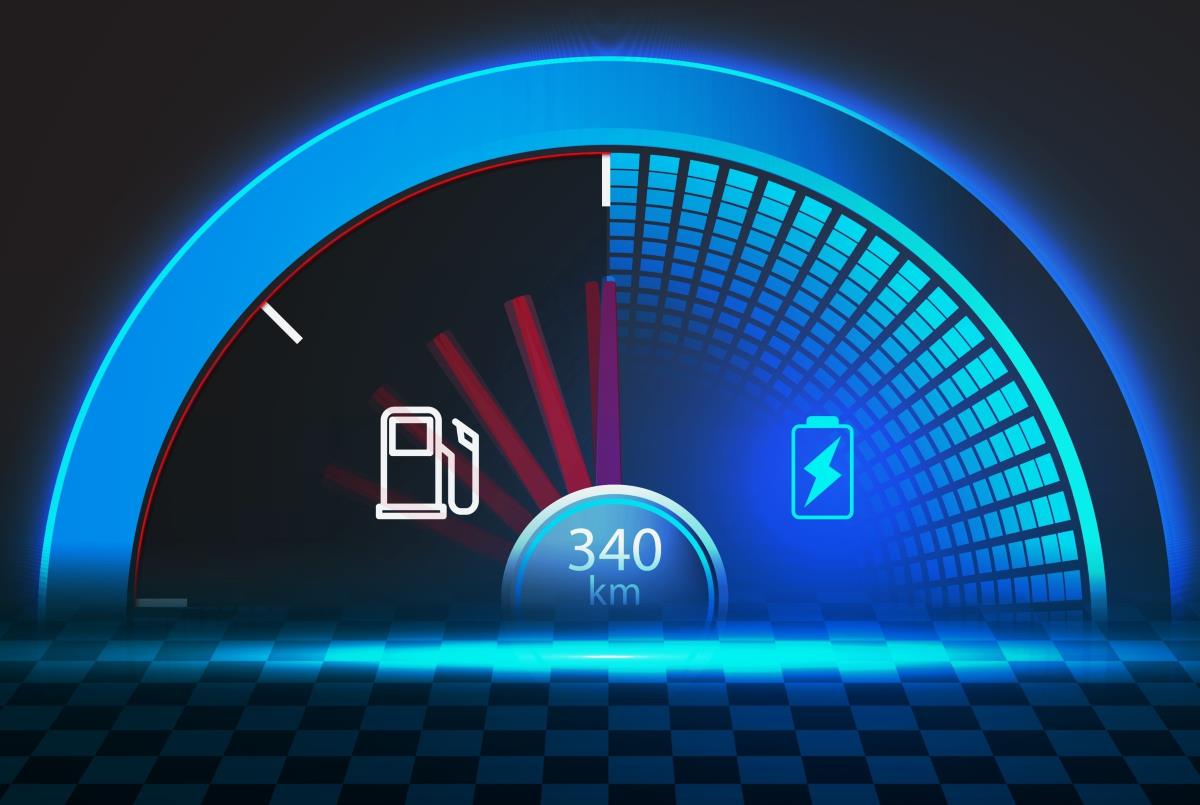
Il Valore Aggiunto è la differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive per l’acquisto di input produttivi, a essa necessari, presso altre aziende.
Quindi rappresenta il valore che i fattori produttivi utilizzati dall’impresa, capitale e lavoro, hanno ‘aggiunto’ agli input acquistati dall’esterno e che consentono di ottenere una data produzione di beni.
Il Valore Aggiunto serve quindi:
- a rimunerare il capitale investito
- a retribuire la forza lavoro impiegata per realizzare i beni stessi
- a generare quel “plus valore” di marxiana memoria che è in eccesso rispetto alla retribuzione della forza lavoro, inteso anche come profitto per gli imprenditori.
Di conseguenza, una riduzione del Valore Aggiunto nella produzione di un bene implica da una parte, una riduzione del lavoro necessario per realizzare il bene stesso, con inevitabile riduzione dei lavoratori o dei loro salari, e dall’altra parte una riduzione di disponibilità finanziaria per remunerare i capitali investiti.
Valore aggiunto dell’endotermico e dell’elettrico
Chiariti questi concetti, vediamo di confrontare il Valore Aggiunto di un veicolo con motore a combustione interna con un veicolo con motore elettrico.
Un motore endotermico è caratterizzato da un’elevata complessità con centinaia di componenti: pistoni, bielle, valvole, astine e bilancieri, albero a gomiti, albero a camme, cinghie di trasmissione e guarnizioni varie.
Inoltre, almeno altri quattro sistemi sono necessari per garantire il funzionamento del motore endotermico:
- il sistema di alimentazione del carburante, con serbatoio, pompa di alimentazione, carburatore, filtro aria e condotti vari;
- il sistema di lubrificazione del motore con serbatoio dell’olio, pompa, filtro, radiatore e condotti vari;
- il sistema di raffreddamento del motore con radiatore, ventole e condotti vari;
- il sistema di trasmissione con frizione e cambio.
Il Valore Aggiunto per realizzare e assemblare tutta la parte meccanica di un veicolo tradizionale è considerevole e determina una quota consistente del valore finale e quindi del costo del veicolo stesso nel suo complesso.
Per contro, i propulsori elettrici sono formati da pochi componenti, con una struttura meno complessa in confronto a quella di un tradizionale motore diesel o a benzina.
Il motore elettrico è composto da uno statore e da un rotore, i quali, alimentati dalla corrente elettrica fornita dalla batteria, generano dei campi elettromagnetici, che producono a loro volta una forza che aziona le ruote attraverso una trasmissione diretta; infatti, in un’auto elettrica non serve né la frizione, né il cambio, né tantomeno un sistema di lubrificazione e di raffreddamento.
In conclusione, un sistema di propulsione elettrica è molto più semplice e veloce da realizzare rispetto a un propulsore a combustione interna.
Di conseguenza il Valore Aggiunto di un propulsore elettrico è notevolmente inferiore rispetto a un sistema a combustione interna e quindi un veicolo elettrico è più semplice e più veloce da costruire; ergo, dovrebbe essere più economico e quindi costare meno.
Oltretutto i motori elettrici riescono a garantire anche un livello molto più alto di efficienza dal punto di vista energetico. Il rendimento, dalla fonte alla ruota, di un’auto elettrica è intorno all’80% contro il 30% massimo di un’auto a benzina. Da non trascurare poi il fatto che i motori elettrici hanno una durata operativa almeno tripla rispetto ai motori endotermici e che i costi di manutenzione dei propulsori elettrici sono decisamente inferiori di circa un ordine di grandezza rispetto ai propulsori termici.
Il fattore prezzo
Il fatto che attualmente i veicoli elettrici siano disponibili a prezzi più elevati di quelli tradizionali dipende da alcuni fattori contingenti:
- le attuali economie di scala, regolate dal concetto di costo marginale, fanno sì che finché non si raggiungono determinati volumi di produzione i costi finali dei veicoli elettrici rimangano elevati per via dei costi fissi di remunerazione dei capitali investiti. Pertanto, meno sono i veicoli elettrici prodotti, più costano;
- finora tutte le case automobilistiche hanno optato per produrre modelli di alta gamma, quindi più costosi, in modo da compensare il basso Valore Aggiunto dei sistemi propulsivi con l’alto Valore Aggiunto delle carrozzerie di lusso e delle conseguenti rifiniture e accessori vari;
- è presente un’offerta massiccia di sistemi ibridi, che consente di incrementare il Valore Aggiunto di ogni singolo veicolo, aggiungendo alla motorizzazione tradizionale, la motorizzazione elettrica;
- i pacchi batteria, che ora raggiungono facilmente il 25% del valore di un’auto elettrica, non vengono prodotti dalle case automobilistiche tradizionali, per cui per gli automakers, il loro Valore Aggiunto è limitato al solo assemblaggio nelle linee di produzione; il costo dei pacchi batteria è comunque in continua diminuzione. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) riporta che i prezzi delle batterie al litio sono diminuiti dai 780 $/kWh del 2013 ai 139 $/kWh del 2023 e che il calo proseguirà nei prossimi anni arrivando a 80 $/kWh nel 2030.
Oltretutto, reti pubbliche di ricarica ancora insufficienti e non uniformate in termini di costo del kWh, abbinate alla nota sindrome di “ansia da ricarica”, tengono lontano dal mercato dell’auto elettrica una vasta moltitudine di utenti pur favorevoli all’elettrificazione della mobilità.
Ma questi fattori sono da considerarsi transitori. Basta osservare il mercato cinese per rendersi conto di cosa sta succedendo e capire come evolverà anche il mercato automobilistico europeo.
La Repubblica popolare cinese, che nel 1990 produceva mezzo milione di veicoli all’anno su un totale mondiale di 48,5 milioni (l’1% del mercato mondiale), nel 2023 ha registrato oltre 26 milioni di nuovi veicoli su un totale mondiale di circa 90 milioni, pari al 32,5%.
A trainare il settore dell’automotive sono sempre di più i veicoli a nuova energia (Nev) che includono quelli a batteria (Bev) e gli ibridi (Phev) e meno quelli con motore a combustione interna (Ice).
Secondo la China Passenger Car Association (Cpca), nel 2023 le macchine elettriche e ibride sono arrivate a costituire il 37,5% del totale delle vendite di auto nuove in Cina. Sia la crescita sostenuta, sia le politiche di sostegno al settore indicano il valore strategico che l’industria dei Nev ha assunto per l’economia cinese.
Con i ritmi attuali si prevede di superare abbondantemente il 50% di penetrazione dei Nev nel mercato dell’automotive entro il 2026.
Occorre rilevare che in Europa e negli Usa la transizione elettrica comporta non solo la costituzione di nuovo capitale fisso, ma la distruzione degli impianti e dell’esperienza tecnologica accumulata per decenni, riconvertendo e addestrando forza lavoro e modificando l’organizzazione delle imprese.
Per la Cina, che non dispone di vecchie strutture produttive consolidate, crearne di nuove finalizzate alla propulsione elettrica è molto più facile e non traumatico come in Occidente.
Oltretutto attribuire il successo cinese unicamente ai sussidi statali è fuorviante, in quanto non si tiene conto dei forti investimenti occidentali e in Giappone (Volkswagen, Tesla, Toyota, Honda, ecc.). Attualmente i costruttori cinesi fanno concorrenza ai produttori occidentali e giapponesi, cosa che è intrinseca nella logica capitalistica di crearsi all’interno i propri nemici.
Infatti, in Cina è scoppiata la guerra dei prezzi. Prima fra tutte, BYD (Build Your Dreams) ha abbassato drasticamente il costo di cinque modelli al di sotto della soglia psicologica dei 100.000 RMB, pari a 12.000 euro.
Ad esempio, la city car Seagull, completamente elettrica e con una autonomia di 300 km, costa meno di 9.000 euro. Da rilevare che BYD produce da sé i pacchi batteria con una quota mondiale del 17% e così integra l’intera catena del Valore Aggiunto (report “Il mercato cinese dell’automotive 2023, tendenze e prospettive” – pdf).
Tuttavia, i produttori cinesi stanno scegliendo di mantenere alti i prezzi sul mercato europeo per non spaventare i produttori europei, vendendo le loro auto elettriche a prezzi più alti di due o tre volte rispetto a quelli del loro mercato interno, per cui, anche se l’Ue introducesse consistenti dazi sulle importazioni, i produttori cinesi sarebbero comunque concorrenziali con gli costruttori europei.
Gli impatti della transizione ai veicoli elettrici
Ma la migrazione della produzione di Valore Aggiunto verso altri soggetti non finisce qui.
La transizione verso la mobilità elettrica, infatti, impatterà fortemente sulle reti di assistenza agli autoveicoli, il cosiddetto “aftermarket”.
Secondo l’Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica (ANFIA), in Italia si contano oltre 83mila officine di autoriparazione con circa 195mila occupati e 14 miliardi di euro di fatturato annuo. Di queste, la categoria più rappresentata è quella dei meccanici-motoristi, con il 52% degli addetti, senza considerare gli addetti dei centri di revisione dei concessionari che contano altre 9.000 unità.
Cosa ne sarà di tutti questi esperti professionisti che spesso riescono a diagnosticare un malfunzionamento semplicemente ascoltando il rombo del motore?
Sicuramente molti dovranno convertirsi e reinventarsi, soprattutto i giovani e molti dovranno ritornare a scuola. La categoria degli elettrauti, che oggi è rappresentata da un misero 9% del totale degli addetti, è destinata ad aumentare esponenzialmente riciclandosi verso l’elettronica di potenza e i relativi software.
Inoltre, nell’ambito del commercio al dettaglio dei carburanti, dove in Italia si contano oltre 50.000 occupati con un fatturato annuo di 31 miliardi di euro, molti benzinai verranno falcidiati dall’avvento della trazione elettrica se non saranno in grado di riconvertire all’elettrico le stazioni di servizio di loro pertinenza.
L’elettrificazione della mobilità è un cambiamento di paradigma tecnologico radicale con effetti distruttivi sulle vecchie filiere di produzione e sugli equilibri oligopolistici dell’intero settore automobilistico che rischia di creare forti tensioni sociali presso decine di migliaia di operatori nel settore dell’automotive, provocando morti e feriti.
Minori costi di costruzione e maggiore durata dei veicoli, minori costi di manutenzione e riparazione, maggiore efficienza dei propulsori e forte riduzione dei consumi di energia primaria, caratterizzeranno l’avvento della mobilità elettrica, comportando, oltre che a una riduzione di valore, il rischio concreto di una rilevante riduzione della forza lavoro occupata in tutta la filiera stessa.
La parola d’ordine è programmazione
La transizione verso la mobilità elettrica è già iniziata, pur con diversi livelli di rapidità.
Se da un lato le imprese maggiormente impegnate nella transizione sono quelle che dispongono di robusti dipartimenti di ricerca e sviluppo, d’altro canto le imprese di piccole dimensioni, che operano nell’ambito della componentistica, sperimenteranno una transizione più lenta con l’ingresso di nuovi concorrenti che imporranno loro di riorganizzare i processi di creazione di valore.
Evidentemente molte criticità, che affliggono tipicamente il sistema industriale italiano, vanno affrontate: mancanza di chiari indirizzi politici, identificazione delle priorità d’investimento, rapporti con la pubblica amministrazione e accesso ai finanziamenti.
Infine, ma non meno importante, manca ancora una connessione con il sistema nazionale e locale dell’istruzione e della formazione professionale, che ha bisogno di poter riorientare rapidamente tutti quegli indirizzi professionali che diventeranno sempre di più obsoleti.
Questo rende urgente riconsiderare e adeguare il sistema dell’istruzione e della formazione professionale alla transizione verso la mobilità elettrica e ciò rappresenta un’altra grande sfida che il paese deve affrontare.
Purtroppo, alcune forze politiche, per lo più del campo conservatore, ma non solo, conducono battaglie di retroguardia e tendono a contrastare e a rallentare la diffusione dei veicoli elettrici, diffondendo le fake-news più disparate, dalla pericolosità delle batterie al rischio di black-out delle reti elettriche, fino all’incubo dell’invasione di veicoli e prodotti cinesi.
Queste forze politiche dovrebbero rendersi conto che il processo di conversione in atto è ormai inarrestabile e che verrà completato nell’arco di un ventennio o poco più.
Sarebbe molto più proficuo orientare le scelte politiche verso la predisposizione di quadri regolatori stabili nell’ambito di nuove politiche industriali che potranno avere un ruolo fondamentale, non solo nel supportare la transizione delle capacità produttive del Paese, ma anche nella consapevolezza di operare per un futuro più sostenibile e duraturo.The post Il valore aggiunto nella filiera automotive e gli impatti della transizione elettrica first appeared on QualEnergia.it.






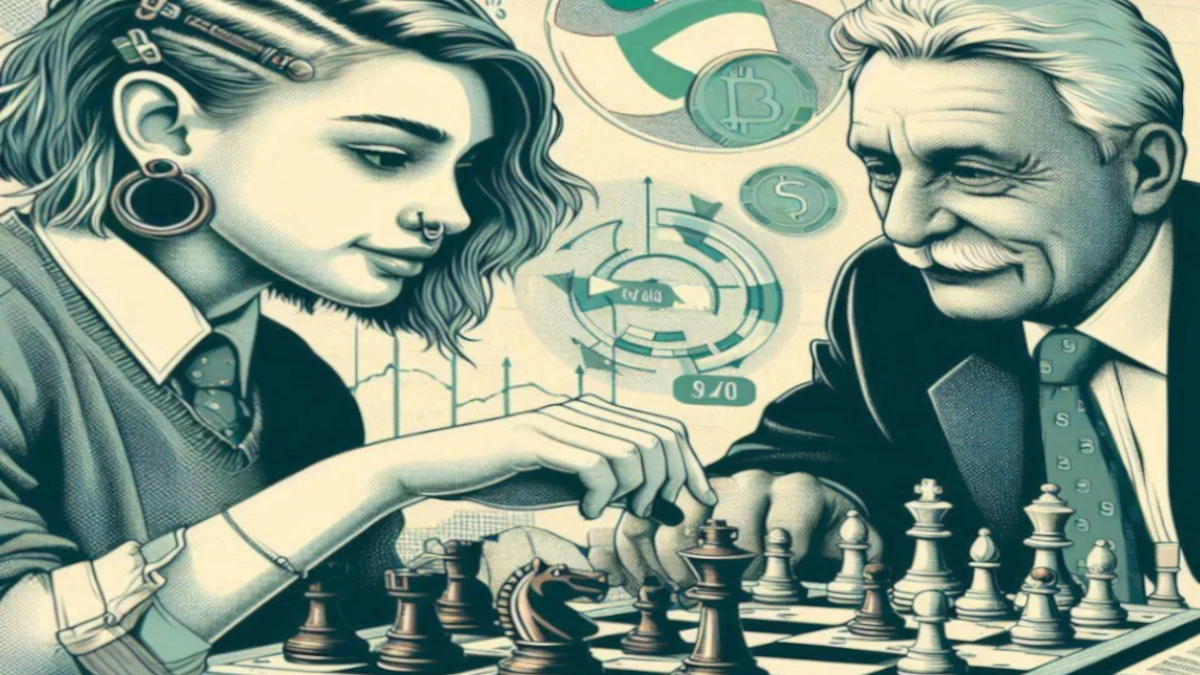
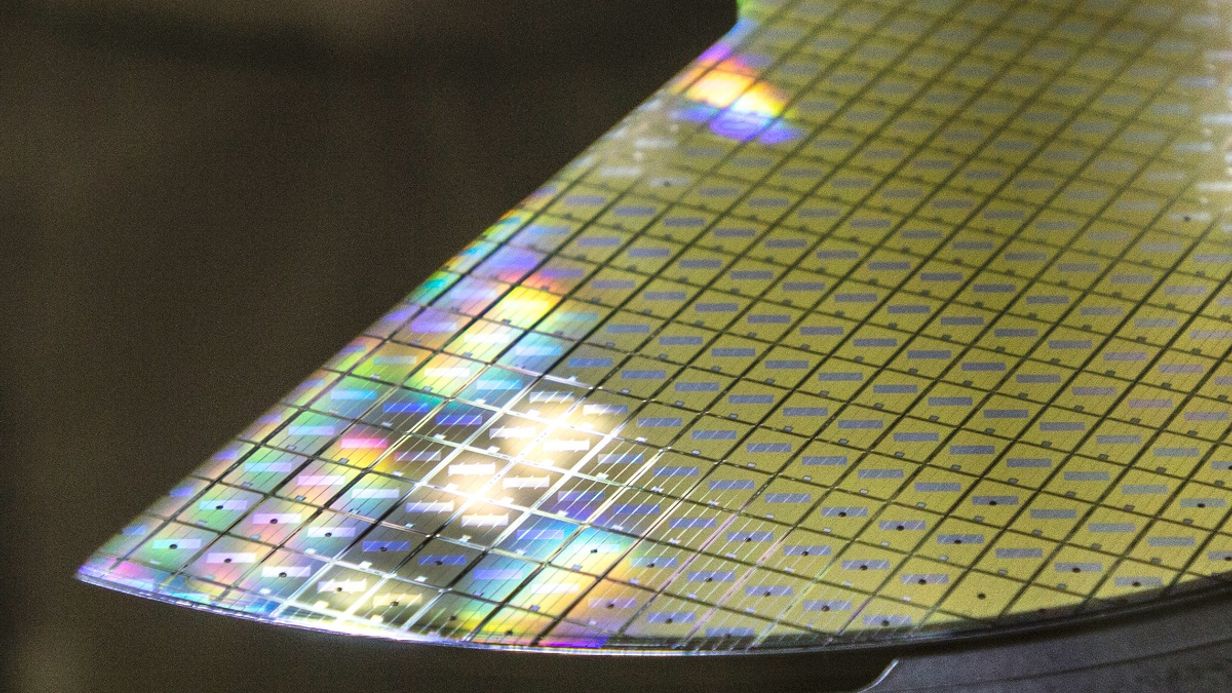

























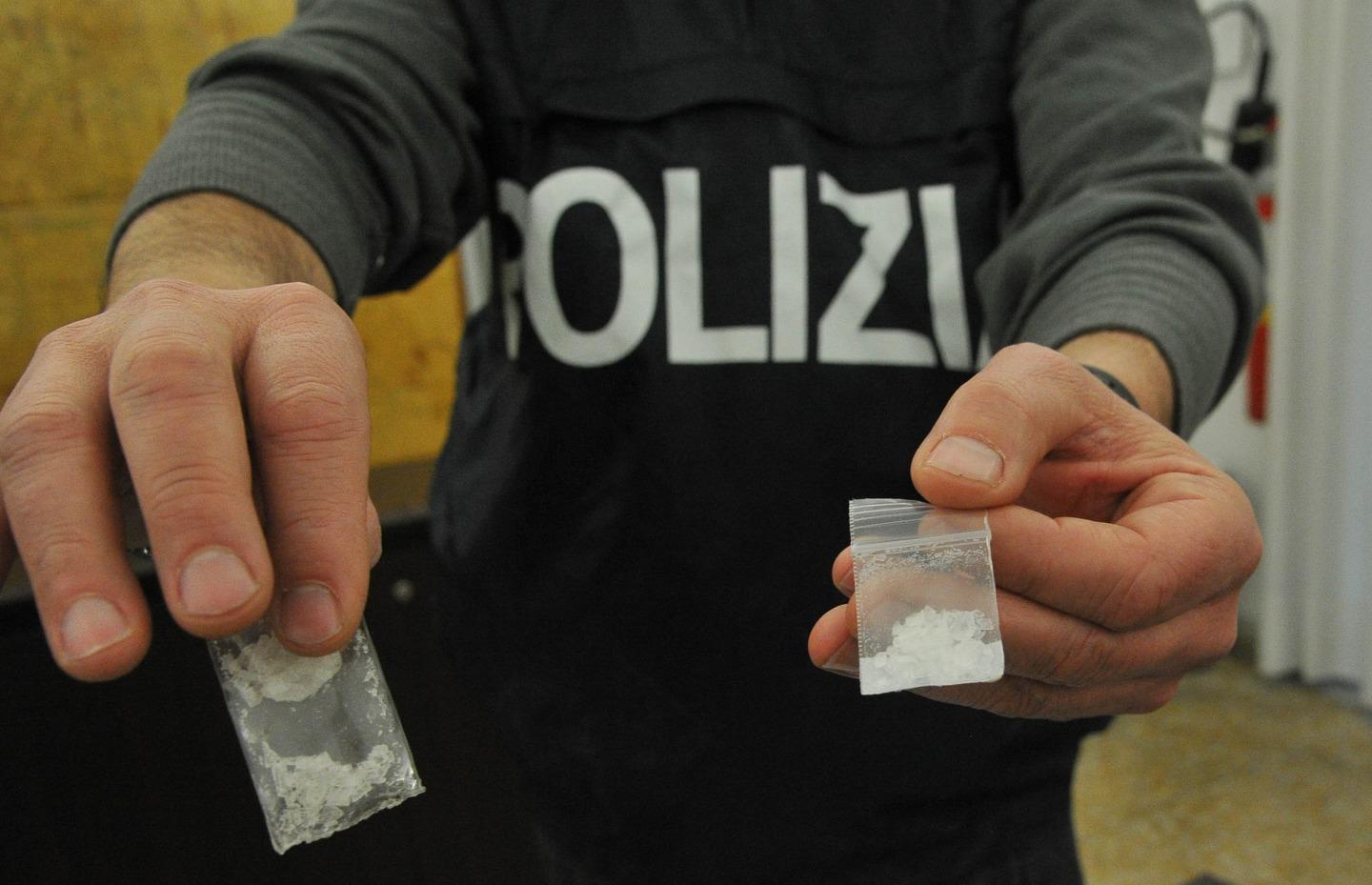







![La guida allo sport in tv oggi [lunedì 3 febbraio] | Il Teleco-Slalom](http://www.loslalom.it/wp-content/uploads/2024/04/tv.jpg)





